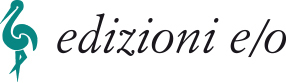Elena Ferrante: "Preferisco non finire in vetrina"
"Preferisco non finire in vetrina" di Elena Ferrante. Articolo apparso su Il Sole 24 Ore, domenica 27 luglio 2008
Cosa significa per me tenermi lontana dai mezzi di comunicazione di massa? Credo che alla radice, oltre ai miei tratti caratteriali, ci sia un desiderio un po’ nevrotico di intangibilità. Nell’esperienza che ne ho, la fatica-piacere di scrivere tocca ogni punto del corpo. Quando il libro è finito, è come se si fosse stati frugati con eccessiva intimità e non si desidera altro che riguadagnare distanza, ritornare integri. Ho scoperto, pubblicando, che un certo sollievo viene dal fatto che il testo, nel momento in cui diventa libro stampato, se ne va altrove. Prima era lui a starmi addosso, ora toccherebbe a me corrergli dietro. Ma ho deciso di non farlo. Desidero poter pensare che, se il mio libro entra nel circuito delle merci, niente sia in grado di obbligarmi a fare il suo stesso percorso. Ma forse voglio anche poter credere, in certi momenti se non sempre, che quel “mio” che gli riferisco sia nella sostanza una convenzione, tanto che chi si disgusterà della storia narrata o se ne entusiasmerà non potrà, con un passaggio logico errato, disgustarsi o entusiasmarsi anche di me. I vecchi miti sull’ispirazione forse dicevano almeno una verità: quando si fa un lavoro creativo si è abitati da altro, in qualche misura si diventa altro. Ma quando si smette di scrivere si ridiventa sé stessi, la persona che comunemente si è, nelle occupazioni, nei pensieri, nel linguaggio. Perciò ora sono di nuovo io, me ne sto qui, faccio le mie cose di tutti i giorni, non c’entro col libro o, per dir meglio, ci sono entrata, ma adesso non posso più entrarci. Né d’altra parte il libro può rientrare in me. Non mi resta quindi che proteggermi dai suoi effetti, ed è quello che cerco di fare. L’ho scritto per liberarmene, non per restarne prigioniera…
Ma i media, specialmente quando connettono foto dell’autore a libro, performance mediatica dello scrittore a copertina dell’opera, vanno proprio in direzione opposta. Aboliscono la distanza tra autore e libro, fanno in modo che l’uno si spenda a favore dell’altro, impastano il primo con i materiali del secondo e viceversa. Provo, di fronte a queste forme di intervento, una specie di “timidezza privata”. Ho lavorato a lungo, precipitando a capofitto dentro la materia che intendevo narrare, per distillare dalle esperienze mie e di altri quanto di “pubblico” era distillabile, quanto mi pareva estraibile da voci, fatti, persone vicine e lontane, per costruire parvenze e un organismo narrativo di qualche pubblica coerenza. Ora che quell’organismo ha, nel bene e nel male, un suo equilibrio autosufficiente, perché dovrei affidarmi ai media? Per continuare a mescolare il suo respiro col mio? Ho il timore fondato che i media, privi per la loro attuale natura di un reale “pubblico interesse”, tenderebbero a ridare sciattamente privatezza a un oggetto che è nato proprio per dare un significato meno circoscritto all’esperienza individuale.
Forse soprattutto quest’ultimo ordine del discorso merita di essere discusso. C’è modo di tutelare il diritto di un autore alla scelta di fissare una volta per sempre, soltanto attraverso la propria scrittura, quanto di sé merita di diventare pubblico? Il mercato editoriale si preoccupa innanzitutto di sapere se l’autore è spendibile in modo da diventare personaggio accattivante e aiutare così il viaggio mercantile della sua opera. Se si cede, almeno in teoria si accetta che l’intera persona, con tutte le sue esperienze e i suoi affetti, sia posta in vendita insieme al libro. Ma le nervature del privato sono troppo reattive. Se vanno allo scoperto, possono dare soltanto spettacolo di dolore o di allegria o di malevolenza o di astio (qualche volta anche di generosità, ma, volenti o nolenti, esibita); sicuramente non possono aggiungere altro all’opera.
Chiudo con questo tema dicendo per ultimo che scrivere sapendo di non dover apparire genera uno spazio di libertà creativa assoluta. È un angolo mio che intendo difendere, ora che l’ho sperimentato. Se ne fossi privata, mi sentirei bruscamente impoverita.