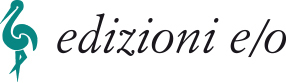Quando la Babuska è una simpatica (e tragica) carogna
Testata: D / La Repubblica delle Donne
Data: 1 ottobre 2011
Quando l'adorata nipotina Aminat la apostrofa chiamandola "nonna cattiva", Rosa si offende solo per la prima parte dell'insulto. Nonna a lei? "A casa mi osservai a lungo, questa volta nel mio scintillante specchio a figura intera. Non avevo affatto l'aspetto di una nonna, in generale. Avevo un bell'aspetto". Rosa è una tremenda donna russa di origine tatara dall'ego ipertrofico che farebbe impallidire Joan Crawford e Bette Davis messe assieme. Fa sempre e solo i suoi interessi. Ha una visione del mondo che non corrisponde alla realtà. È manipolativa, invadente e offensiva. Soprattutto con la figlia Sulfia che considera una povera stupida e deforme. Quando questa rimane incinta vorrebbe risolvere tutto con l'aiuto di un ferro da calza, ma le cose vanno diversamente e nove mesi dopo nasce una nipotina di cui si innamora follemente. "La tenni in braccio e studiai il suo viso. Constatai a sorpresa che quella bambina somigliava più a me che a qualunque altro adulto conoscessi. Contrariamente alla prima impressione, non era brutta. La osservai più attentamente e mi resi conto che in realtà era proprio bella, soprattutto quando stava zitta". I piatti più piccanti della cucina tatara (edizioni e/o), di Alina Bronsky, emigrata dalla Russia all'età di 13 anni in Germania, è una commedia dark in cui tre generazioni di donne sopravvivono al Comunismo, all'emigrazione, alla povertà e alla pedofilia, ma soprattutto alla reciproca presenza. E noi scommettiamo che verrete sedotti dalla verve e dalla cattiveria di Rosa quanto lo siamo stati noi. m.a. Mamma sono incinta! Quando mia figlia Sulfia mi disse che era incinta, ma non sapeva di chi, feci più attenzione del solito al mio portamento. Tenni la schiena perfettamente dritta e le mani dignitosamente intrecciate in grembo. Sulfia era seduta su uno sgabello in cucina. Aveva il collo incassato nelle spalle, una postura molto sgradevole, e gli occhi rossi, perché invece di lasciar scorrere le lacrime si sfregava il viso con il dorso della mano. E questo nonostante le avessi insegnato fin da bambina a piangere senza diventare brutta e a sorridere senza promettere troppo. Ma Sulfia non era sveglia. Anzi, devo dire che era alquanto stupida. In compenso era mia figlia, peggio ancora: la mia unica figlia. Eppure a vederla così, con le spalle curve e il naso che colava, appollaiata sullo sgabello come un pappagallo sul trespolo, provai sentimenti contrastanti. D'istinto avrei voluto gridarle: "Tieni la schiena dritta! Non tirare su col naso! Non fare quella faccia! E guardami negli occhi quando ti parlo!". Però mi faceva anche pena. Nel bene o nel male era pur sempre mia figlia. Altre non ne avevo avute, non avevo avuto nemmeno un maschio, perché da molti anni il mio corpo era vuoto e sterile come la sabbia del deserto. E questa figlia, che invece avevo avuto, era un mostro e non mi si addiceva. Bassa che mi arrivava alle spalle, priva di forme vere e proprie, con gli occhi piccoli e la bocca sbilenca. E per giunta, come ho già detto, stupida. Ormai aveva 17 anni, e nulla lasciava sperare che sarebbe migliorata. La sola speranza che ancora nutrivo era che la sua stupidità stregasse un uomo a tal punto da non fargli notare le gambe storte finché non fossero stati davanti all'ufficiale di stato civile. Finora quella speranza era stata vana. Sulfia aveva due amiche nel nostro caseggiato, ma non parlava con un ragazzo da almeno dieci anni, in pratica da quando aveva iniziato ad andare a scuola. Un giorno però stavo friggendo del pesce (era il 1978 e da un grande laboratorio della città era appena fuoriuscito il bacillo dell'antrace), Sulfia si tappò il naso con la mano e per la quarta volta corse in bagno a vomitare. Lo notò anche quella strega di Klavdia, che aveva una stanza nel nostro comune alloggio. Klavdia lavorava in una clinica, come ostetrica diceva lei, ma io non le ho mai creduto. Al massimo faceva le pulizie. Eravamo coinquiline: abitavamo in un appartamento con due stanze per la mia famiglia, una per lei e bagno e cucina in comune, in un vecchio edificio, bello e molto centrale. E quando Sulfia, appollaiata sullo sgabello, rispose alla mia domanda dicendo che la sua improvvisa gravidanza poteva derivare unicamente dall'aver sognato un uomo durante la notte, le credetti all'istante. Un uomo in carne e ossa non si sarebbe mai avvicinato a Sulfia, a meno che non fosse miope o pervertito. Le strade erano piene di belle ragazze in minigonna. Parlare di atomi "Che lavoro fa esattamente il marito di Sulfia, quel Sergej?", domandai a Kalganov in cucina mentre spezzettava con la forchetta una crêpe ripiena di carne. Lui biascicò qualcosa. Come sempre, aveva la bocca piena. "È un fisico o roba del genere", riuscì a dire alla fine con pezzetti di cipolla tra i denti. "Aha", commentai assorta. "Ma pensa te". Non gli credetti. Cosa sperava di fare mia figlia, che a nove anni non sapeva ancora leggere in maniera decente e a tutt'oggi non sapeva fare i conti, con un fisico? E più che altro, cosa sperava di fare un fisico con mia figlia? Parlare degli atomi? Una mattina alle nove suonai alla porta di Sulfia. Avevo la mia bella pelliccia lunga, il colbacco, un rossetto che denotava il mio buon gusto e una scatola di praline al latte. Erano vecchie, le avevo tenute da parte a lungo per un'occasione speciale. E ora quell'occasione era arrivata. Dietro la porta c'era silenzio. Poi udii fruscii, colpi di tosse e imprecazioni, passi scalzi sul linoleum. La porta si aprì, e per la prima volta vidi un uomo in carne e ossa, che viveva con Sulfia - mio genero. A prima vista dubitai che fosse un fisico. Aveva la faccia da ebete. Uno studioso però doveva essere, visto che non andava a lavorare, era tarda mattinata ed era l'unico ancora in casa. Grosso come un orso, capelli del colore del grano maturo, lunghi, spettinati e ricci. Peli sul petto leggermente più scuri. Gambe... L'uomo si nascose dietro la porta con un balzo. "Cosa c'è?", domandò allungando il collo. "Sono Rosalinda", dissi, e atteggiai la bocca a un sorriso affettuoso. "Mi fa piacere conoscerla finalmente". "Rosa...linda?", ripeté lui in due tappe. Sì, ho un bel nome, sembra preso da un romanzo d'amore straniero. Non sono una Katja o una Larissa qualunque. "Rosalinda..." mormorò. "Ma allora lei...". "Di sicuro mia figlia le avrà parlato molto di me!", tagliai corto, e infilai il tacco alto oltre la soglia. Lui reagì in fretta, forse era davvero un fisico. "Oh, che imbarazzo! È guarita?". "Guarita?" domandai a mia volta, e spinsi la porta con entrambe le mani. Non fu semplice, lui era ancora piazzato dietro. Evidentemente dovetti schiacciare qualcosa, perché lanciò un grido soffocato, si decise a farmi entrare e si profuse in mille scuse. Io annuii con espressione maestosa, mentre lui spariva agilmente dietro l'angolo. Che non era una cosa scontata per uno di quella stazza. Le sue mutande erano nuove e apparentemente pulite. Anche Kalganov aveva bisogno di mutande nuove, stabilii. "Prego, si accomodi, torno subito!" gridò il mio a quanto pareva educato genero dall'altra parte della casa. L'appartamento aveva almeno due camere più la cucina. Mi tolsi la pelliccia, ma decisi di tenere gli stivali. Andai in cucina e mi sedetti su uno sgabello. La stanza era ordinata, minimo otto metri quadrati. Il tavolo era nuovo, e l'incerata anche. La tazza con il coniglio di Aminat era capovolta ad asciugare accanto a un paio di piatti. I fornelli non erano pulitissimi. Sul davanzale erano allineati bicchieri d'acqua con dentro delle cipolle, i cui germogli si allungavano verso il soffitto. Sulfia lo aveva imparato da me: era un modo economico per avere vitamine anche d'inverno. Le vitamine, ora lo sapevo, erano la cosa più importante nella vita. La vista delle cipolle mi tranquillizzò e mi rese tollerante. Decisi che la volta dopo avrei portato a Sulfia un po' della coltura di kombucha che prosperava nella mia cucina. Da quel fungo si otteneva una bevanda particolarmente gustosa e salutare che ricordava il kvas. Ma era molto meglio, perché la birra che si comprava per strada non era certo igienica. (...) Ricomparve mio genero, adesso indossava un accappatoio bisunto. Non avevo ancora ben chiaro cosa pensare di lui. Mi versò del tè freddo in cui galleggiavano ancora le foglie e riempì la tazza di acqua calda. Nel frattempo si informò se il mio cuore stava meglio e chiese com'erano andate le cure. Allora capii. Sulfia, quella piccola carogna, mi aveva tenuta nascosta. Si era liberata di me attribuendomi malattie e ricoveri. Non era certo una soluzione che dava prova di lungimiranza. Il mio cuore batteva regolarmente, lento e stabile, e da molti anni ormai. Di solito erano gli altri che si ammalavano. Tuttavia decisi di stare allo sporco gioco di Sulfia. "Va meglio" dissi. "E lei è soddisfatto del matrimonio?". "Oh sì, molto" rispose mio genero con occhi raggianti. "Sa, ora siamo proprio felici. Da quando la piccola Anja è con noi Soja è letteralmente rifiorita. È stato splendido da parte sua aver aiutato mia moglie in un momento difficile, ma mi sono accorto subito che vuole farcela da sola. Desiderava che la nostra bambina vivesse con noi. Ogni madre normale vuole stare con suo figlio, no?". Inspirai ed espirai. Da quando la mia Aminat era la loro bambina? Da quando Sulfia era una madre normale? Abbandonata? Cinque giorni dopo tornai a casa e trovai una lettera di mio marito sul davanzale della finestra. Diceva che amava un'altra e voleva vivere con lei. Mi ringraziava degli anni passati insieme e mi pregava cortesemente di lasciarlo in pace. Non c'era scritto altro. Ci sono donne che nel ricevere una notizia simile scoppiano in lacrime. Le gambe non le reggono più e loro si accasciano sulle piastrelle a scacchiera della cucina, costringendo gli altri membri della famiglia a scavalcarle se vogliono arrivare al frigorifero. Io non ero una di quelle. Per prima cosa mi preparai un tè, e lo feci a regola d'arte. Riscaldai la teiera e versai sulle foglie l'acqua in ebollizione. Se c'è una cosa che non sopporto è il tè scadente. Bevvi il mio a piccoli sorsi, squisito, mangiai la marmellata di uva spina fatta da me e riflettei. Immaginai di entrare in cucina e non trovare nessuno seduto a tavola ad abbuffarsi. Nessuno che mi snervava mangiando freddo quello che avevo cucinato perché non era stato capace di scaldarlo. E cucinare, poi: avrei potuto quasi smettere. A pranzo mi sarei fatta una zuppa d'avena e a cena un'insalata. Quanto tempo risparmiato! Tempo in cui avrei potuto leggere, guardare la televisione o fare ginnastica. Continuai a riflettere. Non sarei stata costretta a parlare con qualcuno quando tornavo a casa dal lavoro. Cominciai a contare quante camicie a settimana non avrei più dovuto lavare e stirare, e i calzini, i pantaloni, le mutande. La spesa! Non avrei più dovuto trascinare borse piene zeppe perché mi sarebbero bastate molte meno cose. Non avrei più dovuto pulire tutta quella sporcizia perché io non sporco. Avrei potuto parlare con Dio quanto mi pareva e piaceva. Non mi sarei più arrabbiata così tanto perché non c'era nessuno che mi facesse arrabbiare di continuo. E sarei potuta uscire con degli uomini. Uomini nuovi, giovani, che mi avrebbero fatto i complimenti e la mattina dopo sarebbero tornati a casa loro, dalla mamma o dalla fidanzata, per me era lo stesso. Che mi avrebbero fatto sentire di nuovo donna. Devo ammettere che da tempo ormai non mi piaceva più essere toccata da Kalganov. Se involontariamente mi sfiorava una gamba mentre dormiva, la ritraevo schifata. Volontariamente non lo faceva più da un pezzo. Certo, la lettera sul davanzale non aveva solo lati positivi. Si sa che nella vita nessuno ti regala nulla. Dovevo pagare per la mia libertà. Per esempio da quel momento ero una donna abbandonata dal marito. Non era una referenza brillante. Dovevo abituarmi a essere guardata di traverso. Tutto il resto però, con l'aiuto di Dio, era in mano mia. © Alina Bronsky, per gentile concessione dell'editore.