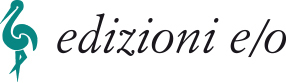Un padre muore lasciando moglie e figlia: una giovanissima esordiente racconta il lutto delle due donne stravolgendo le regole del linguaggio. Settanta acrilico trenta lana è un sorprendente esperimento formale ed emotivo.
Questa storia d’esordio è nata da un buco, un Trauma, un sogno e, in quanto tale, ombelico di esperienza densa e inqualificabile. E visto che i buchi sono molteplici, tutte le parole vi sono cadute dentro per uscirne risanate. Il Trauma di cui parliamo è anche interno al racconto stesso: la morte del padre e marito delle due protagoniste fa, infatti, precipitare la vicenda di una madre un tempo bellissima e della figlia Camelia, che la segue per amore, verso un declino anti-estetico.
Viola Di Grado azzera la lingua e spinge le parole da risignificare verso un tono speciale. L'autrice, ci informa una nota finale, ha 23 anni, si è laureata in lingue orientali e ora studia a Londra. E' una dioscura, una pensatrice che osserva e riqualifica l'immagine del vivere periferico: metronomo dei nostri sussulti e del nostro nulla colmo di "un'inquisizione di viole". Fiori e lame. Una sequenza di errori che svelano il sacro chiuso nel dettaglio e la forma delle cose, che ha sempre una sua arcana necessità.
Viola Di Grado sperimenta un’idea ciclica del romanzo, un romanzo palindromo come gli ideogrammi, plurifocale come la pittura cinese. Quest'ultima ci ha insegnato a vedere il mondo secondo il primato della Natura, da più prospettive simultanee, molto prima che il cubismo impartisse la lezione della temporalità all’Europa. Segno/mondo, segno/significato. "Il linguaggio è una trappola per pesci", afferma Di Grado durante l’intervista che ha rilasciato a Loredana Lipperini su Radio Tre: "quando hai preso i pesci devi dimenticare la trappola".
Allora la materia ottusa del puro linguismo comincia a ridestarsi nella forma alta di una nota difforme dall'indistinto localismo ligustico al quale ci siamo assuefatti, per esplorare porzioni emotive all’interno di uno spazio non logoro, ancora vergine: "Sulla sedia i vestiti storpi sembravano pelli di animali scuoiati. Presi quello con le maniche diverse e in uno slancio di creatività sadica ne amputai una con le forbici. Poi dimezzai la gonna e ricucii la parte tagliata su un altro vestito, di sbieco, come una cintura di sicurezza. Continuai per ore con sfrenato godimento a squarciare pantaloni, mutilare tasche, scambiare bottoni, innestare brutti colletti su altri vestiti ancora più brutti. Finché la bruttezza si fece folgorante, perfetta, e non bastavano più i vestiti del cassonetto, dovevo fare trapianti di stoffe dai vestiti del mio armadio. Così diventavano ancora più brutti, soprattutto quando facevo incroci di laboratorio tra gli orsacchiotti dei pigiami e gli strass dei vestiti da sera, dio che eccitazione".
- Home
- Recensioni
- Viola Di Grado inventa il romanzo palindromo