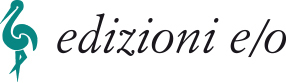A quelle vite segnate dalla perdita manca la parola
Autore: Ermanno Paccagnini
Testata: Corriere della Sera
Data: 3 aprile 2011
È una perdita a segnare il destino dei protagonisti di Settanta acrilico trenta lana dell'esordiente ventitreenne Viola Di Grado. Quella del padre giornalista Stefano Mega che, strappate a Torino la moglie flautista Livia e la figlia Camelia per portarle in una Leeds perennemente e infernalmente invernale, va fuoristrada con la macchina insieme alla giovane amante, assorbiti da una «grossa vagina di terra sporca». È l'inizio d'un destino di perdite singole e comuni per le due donne: all'insegna d'un cupio dissolvi fattosi, da desiderio, accanita volontà di autodissoluzioni. A cominciare dalla perdita della parola, traducendo in «lingua degli sguardi» (in corsivo nel testo) la loro comunicazione, tanto contrastiva da risultare incomunicabilità, e proseguita da Livia nel frenetico fotografare ogni tipo di buco e nella totale dismissione della cura della propria persona. Non è da meno Camelia, traduttrice in inglese di manuali d'istruzione per lavatrici italiane: le cui ossessioni hanno per oggetto vestiti deformati che raccoglie nei cassonetti della spazzatura, sui quali si accanisce sforbiciandoli per poi indossarli, e ogni fiore in cui s'imbatte e che, esistenzialmente ossimorica col proprio nome, «ghigliottina». Situazioni nelle quali si aprono spiragli: allorché Camelia conosce e s'innamora del cinese Wen, dal cui negozio vengono i vestiti che lei raccoglie, scartati perché volutamente rovinati da Jimmy per ripicca nei confronti del fratello Wen; e quando, ma più tardi ancora, la madre esce col maestro del corso di fotografia cui Camelia l'ha iscritta per strapparla alla casa e al suo nero buco mentale. Storie diverse che si ritroveranno però ancora una volta a confliggere, per chiudersi infine nel più cupo noir, da perdite inappellabili, quando la felicità della madre si scontra con la rinnovata solitudine di una Camelia rifiutata da Wen. Una non-storia, quella con Wen: fatta di lezioni di cinese (l'autrice è laureata in lingue orientali) nelle quali s'intromette l'insaziabile, egoistica sensualità di Jimmy, con sullo sfondo il mistero sulla sorte di Lily, una ragazza che prima di lei ha vissuto analoga storia coi due fratelli. Un romanzo che sa essere «racconto» pur recando quale cifra di valore soprattutto una scrittura di forte fisicità, che molto lavora sulle rispondenze metaforiche (a partire dall'onomastica). Ove, nel susseguirsi di più o meno taciti rinvii a valenze simboliche (penso ai dvd mai rispondenti alla copertina promettente silenzi nordici in cui cerca rifugio; o al richiamo a talune atmosfere ghiacce di Björk), assume forte centralità l'elemento comunicativo giocato sui silenzi (o sguardi parlanti) e quegli ideogrammi cinesi che portano la protagonista a riscoprire e decifrare vita e mondo esterno, ma rinvenendo in essi (come nel segno che è, insieme, «buco» e «bambino») il segno dell'ambiguità del vivere e d'un destino ancestrale di vita-morte. Romanzo crudo e crudele, la cui gelida Leeds dell'ambientazione altro non è che metafora di disperate interiorità ed esistenzialità; felicemente sostenuto da una scrittura che sa impregnarsi del delirio (e vi ritrovo legami con Zoo della Santacroce) grazie a un sicuro possesso dello strumento espressivo, fattosi presto sciolto e asciutto dopo un'iniziale compiaciuta insistenza.