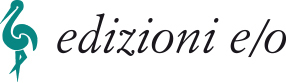«Si è capito subito che gli anni Ottanta sarebbero stati un decennio di merda: al loro inizio ammazzarono John Lennon». È una frase che scrissi qualche tempo fa e della quale mi compiacqui per un bel un po'. Trovavo che condensasse alla perfezione tutto il male di un periodo per me buio del passato recente. La classica frase a effetto che sembra spiegare tutto dicendo praticamente niente. Ripensandoci, non so quanto davvero spieghi o non dica. Ma so che scrivendola non fui molto onesto. Quando iniziarono i maledetti anni Ottanta non ero affatto in dissidio con lo zeitgeist di allora. Imbevuto di idee e rumori post-punk, ero un ragazzino che a modo suo si sentiva come in un pisello nel baccello. Non disprezzavo affatto l'eterno ritorno da quattro soldi degli anni Ottanta, quello che allora veniva chiamato «riflusso».
Nello spirito del tempo Il rigurgito del privato, i moti di schifo per qualunque ideale o ideologia, l'edonismo propinato come valore spirituale dalle emergenti televisioni commerciali il cui profeta sarebbe poi diventato Presidente del Consiglio. Tutto ciò mi appariva cinicamente inevitabile e perfino auspicabile. Figurarsi se mi fregava qualcosa che avevano sparato a John Lennon. Manco sapevo bene chi fosse. Credo non avessi nemmeno chiaro qual era il suo legame coi Beatles, semmai ne aveva uno. Barba e cappelli lunghi, occhialetti ridicoli, l'aria da fraticello depresso. Per me era soltanto il volto di uno sfigato hippy fuori dal tempo. E a quei tempi si diceva che il solo hippy buono è un hippy morto. A voler essere onesti, avevo più cose in comune con Mark David Chapman, il giovane squilibrato che l'8 dicembre 1980 si appostò di fronte al Dakota Building con una rivoltella in tasca intenzionato a sparare a John Lennon. Forse, diversamente da Chapman, non ero abbastanza sciroccato da ergere Il giovane Holden a modello di vita. Ero però abbastanza introverso e invelenito da somigliare ai personaggi asociali di Salinger.
Tutto cominciò a fine anni '70 È vero, gli anni mi hanno cambiato. Ma basta questo a darmi il diritto di uscirmene con certe frasi a effetto? E comunque sia, quando si gioca sporco si rischia di mancare il bersaglio. Se proprio si vuole prendere John Lennon come simbolo della fine di una presunta età dell'oro, non è sulla sua morte che dovrebbe cadere la scelta. Chapman era un fan di Lennon - aveva addirittura sposato una donna di origine giapponese, la sua personale versione di Yoko Ono - e gli scaricò addosso cinque colpi di pistola perché lo incolpava di avere tradito gli ideali della sua generazione.
Un giornalista che si recò all'obitorio scrisse che «in una cella frigorifera, giacevano gli anni Sessanta», ma il folle gesto di Chapman non fu che l'estrema propaggine di una lunga serie di violenti deliri che negli anni Settanta annichilirono i sogni di pace e amore del decennio precedente. In un certo senso tutto cominciò a finire molto prima, nel 1966, quando John Lennon pronunciò una frase destinata a fare scattare la molla decisiva nella testa già alquanto bacata di Chapman. «Adesso siamo più famosi di Gesù Cristo». Lo squinternato omicida non fu però il solo a risentirsi. Quella dichiarazione passò praticamente inosservata in Inghilterra ma scatenò un autentico pandemonio negli Stati Uniti. Molte radio smisero di mandare in onda le canzoni dei Beatles e in varie città si improvvisarono roghi su cui bruciare gli album del quartetto. Anche il Vaticano espresse il suo disappunto. Seppure a suo modo, Lennon si scusò. Ciò nonostante quelle parole lasciarono il segno, i Beatles rimasero insieme ancora quattro anni ma il tour che a esse seguì fu l'ultimo della loro carriera.
Quella sfortunata uscita fu l'avvisaglia di una parabola discendente. La fine vera e propria iniziò però il 16 febbraio 1968 quando i Beatles partirono insieme alle loro fidanzate alla volta di Rishikesh per impratichirsi nella salvifica arte della meditazione trascendentale. Il soggiorno nell'ashram del guru Maharishi fu breve, un paio di settimane appena, ma segnò comunque una sorta di punto di non ritorno nella storia della cultura pop del secolo scorso. Nel corso di quei pochi giorni l'occhio mediatico dell'occidente si concentrò su questa piccola località ai piedi dell'Himalaya senza riuscire a vedere granché, in quanto l'accesso all'ashram del guru Maharishi fu precluso alla stampa. Qualcuno riuscì però a intrufolarsi e a raccontare quel che accade durante questi «altri dieci giorni che cambiarono il mondo».
Quando fu convocato dal caporedattore del Saturday Evening Post per parlare di un eventuale «viaggio in Oriente», Lewis Lapham pensò subito di doversi recare in Vietnam per riferire gli sviluppi di una guerra «che mostrava già i segni di una sconfitta americana». Con sua sorpresa si vide porgere gli ultimi due album dei Beatles e un ritaglio di giornale dove si parlava dell'apparizione al Madison Square Garden dello yogi Maharishi Mahesh dal quale i quattro di Liverpool avrebbero acquisto un po' di consapevolezza cosmica. «Ti unirai a loro sull'eterno cammino dell'illuminazione» si sentì dire Lapham che all'epoca era un giovane promettente giornalista poco informato sull'argomento. «Della band sapevo solo che John Lennon aveva dichiarato all'Evening Standard di Londra che i Beatles erano un evento più rilevante di Gesù Cristo, e il giudizio era probabilmente esatto». Anche la sua conoscenza in materia di filosofie orientali non era particolarmente approfondita.
A ogni buon conto, Lapham accettò la missione di infiltrarsi tra i discepoli del guru così da conquistare la loro fiducia ed essere accolto nell'ashram di Rishikesh nel periodo in cui vi avrebbero soggiornato i Beatles. Scopo ultimo era ovviamente un reportage a puntate da quel nuovo ombelico del mondo, reportage ora raccolto e ampliato in un delizioso volume dal titolo I Beatles in India (edizioni e/o, trad. Alberto Bracci Testasecca, pp. 120, Euro 8,50). Per quanto, definirlo «delizioso» è riduttivo. Scritto con scanzonata, intelligente ed elegante levità, il libro di Lapham è al contempo la cronaca di un piccolo pezzo di Storia e uno spassoso racconto sulla natura umana.
Alla resa dei conti Lapham rivela assai poco su quel che davvero fecero i Beatles in India. Quantunque la sua presenza fosse stata accettata nell'ashram, il giornalista non poté avvicinarli più di tanto e si dovette accontentare di fuggevoli quanto impagabili apparizioni. Ringo Starr che rimpiange di non essere rimasto a casa dove avrebbe potuto mettersi altrettanto bene nella posizione del loto. Uno scettico Paul McCartney che si dichiara «un po' perso ai livelli superiori». John Lennon che fa dei filmini a una folla di indiani sulla riva del Gange e da quegli stessi indiani viene a sua volta fotografato. E George Harrison, il più convinto del gruppo, che ammette di riconoscere alle droghe il potere di riempire vuoti e procurare visioni meravigliose, ma siccome la morte è comunque «un po' una rogna» alla fine anche religione e filosofia hanno la loro utilità.
Quel che in effetti Lapham racconta è l'India delle utopie occidentali, un eldorado dello spirito dove santoni e ciarlatani accolgono anime in fuga - spesso solo temporanea - dal consumismo. Alcune di esse sono celebri o ricche come i Beatles, altre semplicemente in pena e bisognose di trovare il loro posto nel mondo. Come John O'Shea, un ex marine che aveva battuto «le strade di Haight-Ashbury, a San Francisco, vendendo acidi, leggendo Kerouac e tenendosi lontano dalla mischia. Ma poi il quartiere era caduto nelle mani dei filistei, e lui aveva sentito che la mischia si stava avvicinando minacciosa al perimetro del suo karma». Così aveva cominciato a viaggiare per l'India su vagoni di seconda classe, vestito come un sadhu, chiedendo l'elemosina nella ferma intenzione di perdersi.
«Quando sei un sant'uomo è tutto gratis. E nessuno ti rompe i coglioni per l'hashish» spiega il transfuga al giornalista. E se la montagna non va da Maometto, ci pensa il Maharishi ad andare alla montagna, ovvero a fare proseliti in Occidente. Il guru della meditazione trascendentale sbarcò infatti in America nell'ormai non più così vicino 1959. Chissà, forse aveva sentito aria di anni Sessanta. Parlò per la prima volta agli americani sotto un acero del Sequoia National Park in California. Poi si spostò a Hollywood, il che è ben strano: da fautore di pace quale si professava forse avrebbe fatto meglio a considerare prima una capatina al Pentagono. Comunque sia, pare che all'inizio viaggiasse con un semplice tappetino che, arrotolato, gli serviva anche da sacca per i suoi poverissimi beni terreni, quattro stracci e uno spazzolino da denti.
Il Maharishi doveva avere però qualche rudimento di marketing. Grazie a depliant promozionali che lo definivano il «Faro dell'Himalaya» nel giro di poco tempo riuscì a mettere insieme una accolita di discepoli abbastanza vasta e ancor più danarosa da potersi finalmente permettere l'acquisto di una valigia e - gia che c'era - l'apertura di un conto in Svizzera.
Com'è facile immaginare, Lewis Lapham dubita fortemente del fatto che la meditazione trascendentale sia davvero la panacea ideale ai malesseri e alle malefatte del genere umano. Il suo modo di mostrare scetticismo è però misurato, espresso con una lingua così melodica da non risultare mai canzonatorio. In fondo, prova simpatia per i discepoli del Maharishi, sia che si chiamino Mia Farrow o che siano perfetti sconosciuti. E non sembra nemmeno voler screditare più di tanto lui, il guru, malgrado non di rado riferisca pettegolezzi esilaranti in merito alle più alte sfere della consapevolezza: «Al Maharishi non piaceva il nero. Quando si grattava, voleva dire che percepiva atmosfere negative nell'atmosfera».
Tanta voglia di crederci Lo si può capire. Forse i benefici effetti della meditazione trascendentale sono ottenibili con tecniche alternative, qualcuno ha proposto la lettura del dizionario enciclopedico Oxford per tre mesi di fila. E sicuramente suona un tantino sospetto che il mantra da ripetere per venti minuti due volte al giorno comporti un investimento di duemila euro - questa è più o meno la tariffa attuale. Ma quello che le persone sperano di trovarvi - serenità, pace, amore, armonia con se stessi e col cosmo, una risposta qualunque al senso della vita - sono umane necessità. Le più umane delle necessità. Io stesso ho partecipato a un seminario sulla meditazione tenuto da un noto regista americano e da Donovan il quale, praticando questa tecnica da più di trent'anni, era pure lui a Rishikesh insieme ai Beatles. Come Lapham, ne sono uscito con una buona dose di scetticismo ma sarei ancora una volta disonesto se non riconoscessi che, sotto sotto, ho covato molta voglia di crederci. Questa storia della meditazione trascendentale è un po' come credere negli alieni. Se ne può ridere fin che si vuole, ma il problema di fondo non è di poco conto.
Alle spalle degli anni '80 Tuttavia, John Lennon se ne andò via deluso da Rishikes. Aveva sorpreso il Maharishi mentre ci provava con la sorella di Mia Farrow e, insomma, gli sembrava che un santone dovesse essere superiore a certi appetiti. Qualcosa i Beatles ne ricavarono comunque. Scesero dalla montagna con un sacco di nuove canzoni, che sono poi quelle del White Album. Quanto al resto, quel breve viaggio ai piedi dell'Himalaya, segnò il termine della grande ondata di speranze e ottimismo.
Il nero che tanto non piaceva al Maharishi stava prendendo il posto dei colori psichedelici. In aprile avrebbero ucciso Martin Luther King, in giugno Bob Kennedy e nei sei anni successivi altri trentacinquemila giovani sarebbero stati mandati a morire in Vietnam. L'8 dicembre 1980, quando il giovane squilibrato Mark David Chapman si appostava davanti al portone del Dakota Building con una rivoltella in una tasca e Il giovane Holden nell'altra, gli anni Ottanta erano cominciati già da un pezzo.