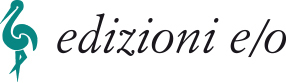Storia di un'identità generata attraverso un atto linguistico
Autore: Isabella Mattazzi
Testata: Alias / Il Manifesto
Data: 4 novembre 2012
La creazione dell’universo, almeno di quello occidentale, è da sempre un atto di parola. Il dio della religione ebraica fa sorgere l’ordine dal caos soffiando, nel vuoto primordiale dell’attesa, una combinazione ragionata di suoni. Nella Genesi, Javeh pone di fonte ad Adamo una schiera infinita di animali e chiede a lui di indicarne il vero nome. Adamo, ancora per poco figlio prediletto e onnisciente, li nomina uno a uno, e con questo atto – linguistico a tutti gli effetti – indovinando e rivelando ad alta voce la loro essenza più intima e radicale, dà agli animali (agli oggetti del mondo) il pieno diritto di esistenza.
Da sempre la vertigine combinatoria del linguaggio sembra corrispondere alla vertigine combinatoria del reale. Edulcorata oggi dai suoi aspetti più terrifici, addomesticata da un sapere sempre più laico, travestita nelle campagne per l’alfabetizzazione contemporanea da mezzo di emancipazione e riscatto sociale, in realtà la pratica di lettura e scrittura è per noi occidentali un vero e proprio atto di creazione. Colui che ne conosce i segreti, di fatto, possiede la chiave dell’essere. Chi legge, chi scrive tiene in mano gli ordini degli anni e dei mondi. Ma cosa succede allora a chi “non conosce”? Come si muove chi non sa leggere, chi non scrive, chi ignora la possibilità infinita nascosta nei suoni e il loro perfetto aderire alla verità del reale?
In Mandorle amare, l’ultimo e sicuramente il più riuscito romanzo di Laurence Cossé (in Italia appena uscito per E/O con la traduzione di Alberto Bracci Testasecca, pp.176, 17 euro), due donne siedono l’una di fronte all’altra. Da una parte del tavolo, Édith, francese, traduttrice editoriale di alto livello, donna colta, dalla sicurezza linguistica non solo di chi appartiene al mondo occidentale (e ne sa utilizzare i codici), ma anche di chi ha imparato più di un linguaggio ed è perfettamente in grado di passare dall’uno all’altro, facendoli giocare tra loro in quella vera e propria arte del virtuosismo verbale che di fatto è la traduzione letteraria.
Dall’altra Fadila, la sua domestica, immigrata marocchina, mai scolarizzata, (analfabeta sotto tutti i punti di vista, dal momento che non solo non sa leggere e scrivere in francese, ma neppure in arabo). Una donna nata nel Marocco degli anni Quaranta dove i bambini dei paesi più piccoli e decentrati non conoscevano le matite, neppure quelle per disegnare. Una persona al grado zero del linguaggio, per cui la scrittura non è neppure un gesto, ma qualcosa di assolutamente estraneo, un’attività marziana, inconcepibile. In mezzo a loro, un nome, Fadila Amrani, scritto in lettere cubitali su un foglietto perché la domestica lo impari, perché impari a distinguerne i suoni, a separare le vocali dalle consonanti, e poi a riprodurle, prima guidata e poi da sola, risalendo da lì, da quella sequenza ordinata di lettere, tutta l’intera catena dell’essere.
Intorno alla scrittura delle parole Fadila e Amrani, intorno alla loro individuazione, alla loro lettura e scrittura si gioca l’intero romanzo. Un romanzo che solo apparentemente è un testo sociale o politico (Édith vuole che Fadila impari a leggere e scrivere per renderla libera di riconoscere senza aiuto le fermate della metropolitana, perché firmi con il proprio nome un assegno, perché possa compilare un modulo per la pensione, perché impari a far di conto nei negozi e a capire il prezzo della frutta e della verdura), ma che in realtà pone dei problemi di ordine strettamente metafisico. Se nominare l’universo equivale a crearlo, a “far sì che sia”, imparare il proprio nome, nominare se stessi, equivale a mettersi da soli al mondo, a partorire la propria identità attraverso un atto linguistico che ha tutti gli aspetti di un gesto demiurgico. La storia di Mandorle amare è la storia di un parto, del parto di un nome e di una persona attraverso il proprio nome. Un parto difficile. Un parto alla fine del tutto mancato.
Fadila, giorno dopo giorno, mese dopo mese, non sembra imparare mai. Adamo recalcitrante, impossibilitato a dire il “giusto nome” di se stesso, si perde nel gioco combinatorio, confonde le vocali, non le riconosce, non vede. Fadila Amrani nome, rimane sul tavolo, eidolon platonico impossibile da essere anche solo memorizzato, ogni volta scomposto, fatto a pezzi e mai ricostruito. Fadila Amrani donna, rimane un essere sempre a metà, mai veramente cosciente della propria dignità, mai messa veramente al mondo da se stessa. Una non-nascita che non riguarda soltanto la sua vita difficile da immigrata in suolo francese, ma la sua identità stessa di donna marocchina, da sempre passiva, violentata dal primo marito, poi venduta a un altro, molto poco amata, mai rispettata, neppure dai figli.
Di fronte al cataclisma della creazione imperfetta, di fronte all’evidente incapacità della propria allieva, Édith riprende comunque il filo ogni giorno, paziente, tenace. Per ogni Amrani sbagliato, per ogni lettera invertita, per ogni suono non ben individuato, c’è sempre una rimessa in discussione da parte di Édith sui suoi metodi educativi, una serie di dubbi, magari la decisione di tentare un nuovo metodo, ma mai una dichiarazione di sconfitta. Per lei – e con ogni evidenza per la stessa Laurence Cossé – senza linguaggio non c’è scampo. In una prospettiva di studi postcoloniali, l’altro da noi è per definizione colui che non può parlare. Chi è stato posto come altro, non può per forza di cose utilizzare lo stesso linguaggio di colui che lo nomina. Non ha voce, non ha parola. Il rifiuto (fisico o psicologico che sia) di Fadila di imparare il proprio nome condanna quindi la donna, all’interno delle logiche del romanzo, al ruolo di alterità assoluta e, in seconda istanza, di soggetto a tutti gli effetti perdente.
A Fadila non può venir perdonato il suo analfabetismo. Se in Mandorle amare non c’è altra salvezza che nel dominio dei suoni e della scrittura, per lei non c’è posto. Con il proprio nome ancora incerto, disperso in una manciata di fogliettini spiegazzati, viene investita da una macchina e ridotta in coma. La tac mostra lesioni irreversibili, Fadila non vede e non sente più, ridotta alla dimensione di puro e semplice macchinario organico. La sua condizione di non-nascita si trasforma così in una condizione di non-vita a tutti gli effetti. Sarcofago di se stessa, corpo percorso da tubi e valvole, retrocede alla condizione di massa inanimata, di creatura liminale. È l’informe prelinguistico. Il caos che precede ogni nome. “Édith le mette la mano nella mano. Il calore della pelle le fa tornare alla memoria le volte in cui le ha tenuto la mano per scrivere insieme. Le viene in mente una cosa crudele. Se cercasse adesso di stabilire una comunicazione con Fadila dicendole di esprimersi lettera dopo lettera e parola dopo parola chiudendo le palpebre una volta per dire A, due per dire B e così via, come il Dantès di Dumas, lei non potrebbe. Édith percepisce sul palmo, lancinanti, l’alfa e l’omega del suo fallimento, non è riuscita a insegnare l’alfabeto a Fadila”.