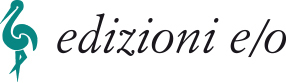Il secondo romanzo di Viola Di Grado portava con sé un carico di aspettative tali (come ogni post-esordio) che,per un esubero di empatia, ho davvero un po’ temuto per le sue sorti. Che fatica appassionarsi. Non dirò com’è andata, se sono delusa, se sono entusiasta. Rivelare un’aspettativa o un’impressione mal si combina con l’intento mistico di Cuore cavo (Edizioni e/o, 2013), con la sua esortazione a essere giglio, roccia, fiume, sabbia.
Chiamando a raccolta il Tao, la grazia delle ninfe e la protezione delle antenate scrittrici, Viola Di Grado si è confrontata con un misticismo concreto, pagano, materico e oltremodo umano. E ha messo in piedi un delicatissimo inno alla vita.
Il mio sangue alla base dell’Etna, sotterraneo, arginato dalla roccia. Il mio sangue che spinge da sotto gli steli e le radici delle querce. Raggrumato dentro ogni pianta, prosciugato nella bocca aperta di ogni petunia rossa. Inspirare, adesso, è vento.
Dorotea Giglio, da viva, viene – nell’ordine – rifiutata dal padre, poco amata dalla madre, salvata e poi lasciata dal fidanzato. Le questioni terrene più urgenti, l’abbandono, il desiderio, il riconoscimento, hanno creato un cortocircuito di dolore durato venticinque anni, una mosca cieca di strazio d’amore. Antidepressivi, sforzi, psichiatri. Una fatica immane per migliorare, andata a vuoto, meglio rimanere disperati e pieni di impossibilità, lanciati nel futuro, accucciati nel passato. La protagonista, in uno slancio di ottimismo estremo, muore per smettere di soffrire.
Il desiderio è la cosa che mi manca di più di quando ero in vita.
Dorotea, come una ninfa impazzita, regale, sfrontata nella sua rappresentazionedel desiderio, si sdraia nell’acqua, si taglia le vene e prende a vagare nel mondo. La sua morte smuove la terra, le leggi del cosmo cominciano a vivere dall’interno, Dorotea diventa tutto e tutto è Dorotea.
Incarnato da una mitologia buffa, popolata da Violet Trefusis, Amy Whinehouse, e Sinéad O’Connor (e attorno a cui si aggira, silenziosa, l’adorata Sylvia Plath), fatta di metalli, di larve e di petunie rosse, si svela e poi subito si vela il senso della vita che sembra nostalgia e non ha nome.
Una volta morti, il futuro smette di essere un’ossessione, nessuna ansia da interpretazione infinita e al suo posto la rivelazione di come il desiderio muova le fila e ingarbugli i destini – il Buddha ci insegna. L’amore incondizionato, invece, vince su tutto, raccoglie ogni cosa.
Struggente l’ossessione d’amore di Dorotea per la madre, così perturbante da commuovere. Una madre che non sa troppo amare cresce una figlia che la venera e la accudisce. Quasi un nesso logico, nessun romanticismo.
Romanticissima Viola Di Grado, oscura e vagamente divina.
Dorotea da morta, in una tragedia di linguaggio non corrisposto, sta vicino alla madre, le rimbocca le coperte, si sdraia accanto a lei durante i suoi amplessi, versa dell’acqua bollente in faccia a Uomo, l’amante maldestro.
Portò a mia madre dei fiori. Io li rubai dal vaso e andai a portarli alla mia tomba, sostituendoli a quelli secchi.
E se In Settanta acrilico trenta lana la scrittrice ha compiuto un lavoro meraviglioso sul linguaggio, in questo suo secondo romanzo al posto delle parole sta la materia, al posto dello scarto incolmabile tra cose e parole sta l’incolmabilità tra corpo, pensiero e sensi; se è vero che dai pensieri cresce un po’ di anima, trovare il luogo dell’Io sembra impossibile.
La morte è rappresentata in tutta la sua incomunicabilità, il punto esatto attorno a cui lavora la scrittrice, il corpo si fa linguaggio, i morti non si occupano più del senso. La protagonista non può più leggere, non riesce a parlare con i vivi, non li può toccare. Un simbolo perfetto, fatto di carne che si decompone, della distanza tra noi e l’altro e dei limiti della parola. Al disfacimento fisico di Dorotea è affidato un lirismo bellissimo, un commovente messaggio d’amore e di compassione per sé che possiede la forza e la generosità di un’esortazione.
05/02/2012, ore 24.00: ho così tanta pena per il mio corpo. Mi pento di non avergli mostrato abbastanza gratitudine, quand’ero ancora in tempo. Vorrei ringraziarlo per le sensazionali guerre ai virus, la perfezione della fame e del dolore. Vorrei farlo, ma è troppo tardi.
- Home
- Recensioni
- Cuore cavo, Viola Di Grado