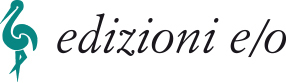«Due giorni dopo essermi ucciso ho trovato lavoro in una pizzeria che si chiama kamikaze». Così comincia uno dei libri di Etgar Keret di maggiore successo in Italia. Una sorta di epica visionaria contro la violenza religiosa e “la cultura della morte” condotta sul filo di una freschissima invenzione narrativa. Situazioni spiazzanti e massicce dosi di ironia e humour nero sono gli ingredienti esplosivi della prosa di Keret, giovane scrittore israeliano, decisamente poco allineato e politically correct. Anche rispetto al governo del suo Paese. Che combatte con le armi, non convenzionali, di folgoranti racconti, di immaginifici graphic novels – e più di recente – anche con la macchina da presa, nel film Meduse, realizzato con l’attrice Shira Geffen. Con lei Etgar vive a Tel Aviv, dove lo abbiamo raggiunto poco prima della sua partenza per la Fiera del libro. Per parlar della sua nuova raccolta di racconti Abram Kadabram, (edizioni e/o), ma non solo.
Hai raccontato di aver cominciato a scrivere per far fronte alla depressione in cui eri caduto durante il servizio militare. La scrittura, insomma, ti ha permesso di appendere al chiodo la divisa. Dove affondano le radici di questo tuo particolare talento per i racconti brevi?
Credo che ogni scrittore parta da un’esigenza tutta sua. Molti usano la scrittura per avere un controllo sulle cose. Per me è l’opposto: scrivo per perdere il controllo. Sono un tipo piuttosto stressato e ossessivo. Il racconto breve mi fa sentire come se camminassi sul filo. Le storia più belle nascono sempre da una fantasia inconscia. La mia, temo, ha una cifra piuttosto nera.
Nelle tue storie si avverte un eco della musicalità, del gusto per la battuta fulminante e corrosiva della tradizione yiddish. Che rapporto hai con quella particolare cultura ebraica preolocausto?
Adoro scrittori yiddish come Singer e Shalom Aleychem. Mi sento decisamente molto più vicino ad autori yiddish e ebrei della diaspora come Kafka e Babela che alla tradizione letteraria israeliana.
Oltre a Kafka citi spesso Kurt Vonnegut.
Di entrambi apprezzo molto il loro riuscire a essere morali senza diventare moralistici. Entrambi non dicono mai al lettore cosa dovrebbe fare, ma riescono sempre a portarlo a un punto di autenticità e di profonda introspezione.
Si dice che il tuo L’autista che voleva essere dio sia stato l’unico titolo di uno scrittore israeliano pubblicato in Palestina, dai tempi dell’ultima intifada. È davvero così?
Non sono sicuro al 100 per cento che sia stato il solo libro, ma di sicuro è stato il primo.
Che impressione ti ha fatto?
Da alcuni lettori palestinesi che mi hanno contattato ho saputo che ciò che più li ha colpiti del libro è il volto di Israele che ne emerge, diverso da quello che generalmente hanno conosciuto nella vita reale e nei libri. Un volto di Israele confuso, spaventato e insicuro.
Credo che questo abbia fatto loro sentire Israele meno distante. Dal libro viene fuori qualcosa di diverso dalla solita ideologia israeliana destrorsa che hanno sempre conosciuto, indipendentemente dal fatto che a incarnarla fosse la destra o certa sinistra liberale.
Con lo scrittore palestinese Samir El Yussef hai pubblicato Gaza blues. Com’è nata la vostra collaborazione?
È stata un’idea di Samir all’epoca dell’Intifada. Sentiva che dovevamo fare qualcosa. Per lui questo libro era una dichiarazione, un manifesto, di possibile coesistenza. «Se la nostra gente non può convivere nella vita di tutti i giorni – diceva Samir – dimostriamo almeno che possono convivere nelle pagine di un libro». Abbiamo lavorato a questo libro come fosse un progetto terapeutico per noi stessi più che un libro che doveva andare in mano ai lettori. Il successo di pubblico che ha avuto ci ha colti davvero di sorpresa.
In Gaza blues si parla di strani personaggi che, una volta vivevano sulla luna e lì riuscivano a dare ai propri pensieri la forma che più desideravano. In Abram Kadabram uno dei protagonisti, Ko Samui, invita la gente a chiudere gli occhi e sognare. Un tema che attraversa come un filo rosso i tuoi racconti.
Penso che le mie storie nascano dalla stessa fonte da cui vengono i sogni. E, come i sogni, raccontano per immagini, strane, condensate, eppure con una loro logica intrinseca. Sognare è fondamentale, ti permette di trascendere la realtà fisica e materiale e di mantenere viva la speranza e la sensazione che ci possa essere un modo migliore, più gentile, di vivere, al quale poter aspirare. Senza sogni non potrei mai sopravvivere emotivamente in questo paese.
Il poeta israeliano Aaron Shabatay ha detto che la Fiera è da condannare perché ha fatto «la scelta politica» di invitare Israele mentre i palestinesi continuano ad essere ammazzati e Gaza è ridotta a un ghetto. Che ne pensi?
Sono convinto che non potremo mai arrivare a una soluzione senza un vero dialogo. Negando il dialogo in genere, quello fra scrittori e intellettuali in particolare, la stagnazione è certa. Parlare di boicottaggio culturale è un ossimoro, una contraddizione in termini. Non c’è niente di culturale nel sottrarsi al confronto fra persone. Gli scrittori rappresentano, forse, la voce più forte e importante contro l’occupazione israeliana dei territori palestinesi. Ma anche se, per ipotesi, ci fosse una frangia di scrittori israeliani di destra, a mio avviso, dovrebbero essere ugualmente invitati a partecipare al confronto. Ho passato la vita a discutere e a scontrarmi con persone che non la pensavano come me. Sono convinto che fare una dialettica con l’altro sia meglio che ignorarlo.
Una volta hai accusato lo scrittore Yehoshua di coltivare una visione dei palestinesi, tutta sua, senza conoscerli realmente. Perché?
In realtà non parlavo di lui, personalmente, ma di un largo gruppo di intellettuali israeliani che hanno preso l’abitudine di andare in giro a spiegare agli altri quali siano i veri bisogni dei palestinesi. Non mi piace, perché c’è qualcosa di paternalistico in tutto questo. Posso aiutare l’altro a essere presente con la sua voce, ma non posso mettermi a fare fantasticherie sui suoi desideri e necessità.
In Italia Fazi ha da poco tradotto La pulizia etnica della Palestina dell’israeliano Alan Pappe. Un libro di fortissima denuncia.
Talvolta accade che le persone autentiche, con una forte morale, nel tentativo giustissimo di rimediare a errori del passato, rischino di rimanere imprigionati nella gabbia di un’ideologia. Arrivando al punto di sostituire una versione distorta della storia con un’altra. Ho incontrato Pappe di persona, si capisce subito che è un uomo di grande integrità. Ma estremizzando la sua posizione fino al punto di parlare di pulizia etnica finisce per autoemarginarsi. Tante persone non ascoltano più le sue idee e ciò che di importante ha da dire.