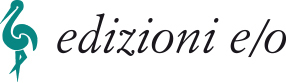Le lacerazioni della Di Grado
Autore: Giulio Ferroni
Testata: Il Manifesto
Data: 27 marzo 2011
La scorsa settimana su queste pagine Daniele Giglioli ha notato come nella narrativa più recente si dia una sorta di crollo della «scrittura», nel quadro dell'emergere di una condizione postmediale, caratterizzata dall'indifferenza per il rilievo del medium utilizzato. Se questo accade per molti esordienti (e, ahimé, anche per molti narratori in testa alle classifiche), non è proprio il caso della ventitreenne Viola Di Grado, che con Settanta acrilico trenta lana (e/o, pp. 191, € 16,00) ci dà una formidabile prova di scrittura: entro la rappresentazione di un mondo cupo e lacerato, tra malessere, degradazione, desiderio, rabbia verso il mondo che rovinosamente precipita. Il racconto è in bocca a una ragazza stralunata e un po' dark, chiusa dentro un proprio universo assurdamente circoscritto, dove si muove con una sorta di maniacale metodicità, come se ne avesse a priori misurato i limiti, sottoscrivendone le condizioni e impegnandosi eroicamente a non uscirne, pur tra prove di fuga, aspirazioni sempre rientrate a una improbabile felicità. Il mondo chiuso è quello di una città inglese che nei suoi tratti di squallore si presenta come un emblema della attuale condizione postindustriale (non nel senso di quell'uscita dal mondo industriale di cui blaterano i tardi apologeti del postmoderno, ma in quello del suo moltiplicarsi e sfaldarsi, del suo produrre scarti e residui, con invasione di stracciati simulacri). E non si tratta di una generica «città inglese», ma di una città vera e propria, Leeds, con i suoi luoghi senza qualità, negozi, parchi, caseggiati, strade, tutto precisamente identificato, come quella Christopher Road in cui all'inizio la protagonista-narratrice, l'italiana Camelia che vive lì da alcuni anni con la madre, dopo la morte del padre, che era venuto lì a fare il cronista, getta in un cassonetto una «nuovissima giacca fucsia». Ed è paradossale cominciare da lì, perché, come ci dice Camelia, «a Christopher Road non succede mai niente. Semmai finisce. Finisce tutto, anche le cose che non sono mai cominciate…». Per lungo tratto del romanzo questa Leeds appare bloccata in un perpetuo inverno, che Camelia registra con continui turbamenti della cronologia, che toccano sia la successione delle ore che quella dei giorni, con un calendario che sembra incepparsi nel passaggio tra il 2004 e il 2005: quando poi si affaccerà la primavera, sembrerà darsi come un sogno illusorio, che accende una speranza accettata contro voglia, che non può che negarsi e dissolversi. Se Camelia ha quel nome di fiore, che per noi può evocare perfino la lontanissima dame aux camélias, il suo mondo è invece quello degli scarti del consumo, dove sono perpetuamente in agguato oggetti rovinati, lacerati, desueti già prima di essere usati: e insistente è la sua lotta con i vestiti, che molto presto la porta a indossare abiti impropri, tagliati in modo irregolare, con improprie aperture, con buchi emancanze di pezzi (di cui si scoprirà a un certo punto l'origine). Ma oltre che dagli oggetti, e più che dagli oggetti, Camelia è ossessionata dal linguaggio, e non soltanto per la sua condizione di italiana che si trova immersa nell'universo anglofono (dove, dopo aver rinunciato all'università, tenta anche di guadagnare qualcosa traducendo in inglese istruzioni per lavatrici di una ditta italiana). Ella pensa che «sono le parole che sono contrarie alla vita, ti nascono in testa, te le covi in gola, e poi in un attimo ci spargi sopra la voce e le uccidi per sempre. La lingua è un crematorio incosciente che vuole condividere e invece distrugge ». Cerca allora di bloccare le parole; e a questo del resto la spinge il comportamento della madre, che, caduta nella disperazione dopo la morte del marito (perito in un incidente mentre la tradiva con un'amante), ha come spento la propria voce di cantante lirica, smettendo completamente di parlare e giungendo a una degradazione estrema, oltre un mero stato vegetativo, comunicando con la figlia solo attraverso gli sguardi. Il linguaggio degli sguardi offre molteplici variazioni nel corso del romanzo: ma presto a esso si sovrappone il linguaggio degli ideogrammi cinesi, che Camelia apprende frequentando un ragazzo cinese, che gestisce un negozio di vestiti, Wen, di cui si innamora (o crede di innamorarsi). Viola Di Grado (competente e studiosa di lingue orientali), nel seguire lo studio che con Wen Camelia viene a fare del cinese, offre un vario, estroso e deformante gioco con gli ideogrammi, con la loro evidenza visiva, come cercando nella materialità del linguaggio, nella sua sostanza oggettuale, non meramente fonetica, una sorta di farmaco o antidoto all'incontrollabilità del mondo, al perpetuo degradarsi delle cose e delle vite («Gli ideogrammi che io non significo nullama loro invece sono unità significanti, come diavolo si dice, morfosillabici»). Nella gestione quotidiana della casa dove vive, Camelia si trova a fare un uso incongruo non solo dei vestiti e del linguaggio, ma dei vari oggetti e utensili domestici; e si accanisce contro la natura che ostenta bellezza, cospirando contro la bruttezza, tanto viva nell'accumulo di oggetti artificiali, nella vita di tanti esseri umani. Di questa sua rabbia contro la bellezza sono vittime proprio i fiori, che ella strazia e violenta appena le capitano sotto tiro: «Se non fai attenzione camminando verso il centro ti ritrovi circondato da un'orgia di fiori gialli, e allora che puoi fare se non distruggerli, io li ammazzavo a uno a uno, li strozzavo con orgoglio necrofilo dentro la borsa». Così se la prende con una «petunia terminale» che ha sfiorato una sua gamba: «c'è un buco che ti aspetta, lì dentro ci pisciano i cani e ci scopano gli uomini, e poi muoiono tutti, uomini e cani, tutti insieme, anche se hanno cercato di chiudere il buco col cemento, e tu cosa credi, stupida, che la tua bellezza ti salverà?». Dai buchi, dalle fessure in cui le cose e le vite possono confluire, precipitare, perdersi, Camelia è ossessionata, come lo è la madre, che con una Polaroid fotografa buchi di ogni sorta, con inquietante sistematicità. In un filo continuo il romanzo lega le ossessioni molteplici che costituiscono il personaggio di Camelia, il mondo di cui ella è prigioniera, le strade ingannevoli attraverso cui prova a uscirne: con un coerente sviluppo di figure che ritornano, con una disponibilità a far passare il linguaggio dal più disinvolto livello colloquiale (che segue anche i correnti modi «giovanili ») agli scatti più rabbiosi, alle più concentrate e penetranti fissazioni di figure, di gesti, di ambienti, fino a certe amare formule morali, quasi di sapore classico, in cui la solitudine della protagonista si proietta sullo sfondo dell'indifferente incoscienza collettiva (ad esempio: «Si chiama vita il gioco che fanno tutti gli esseri umani senza di me»; «Il rumore della tempesta, quello dei binari, quello degli esseri umani che parlano, come se non ci fosse abbastanza rumore, ecco cosa siamo, rumore che si aggiunge al rumore»). Con ostinata intensità la giovane autrice sa immergersi e immergerci in questo universo fatto di scarti, di falle, di residui, dove anche ciò che, come àncora di salvezza, sembra venire da lontano (qui soprattutto il gioco col linguaggio e il fascino della lingua cinese con i suoi ideogrammi) non garantisce redenzioni,ma resta preso nell'imperante e rumoroso artificio, nella neutra e ostile indifferenza di quel tessuto (tanto essenziale è qui la deformazione dei vestiti!), settanta acrilico trenta lana.