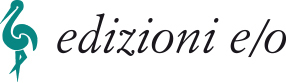Ebreo, israeliano, sionista: concetti da precisare (Edizioni e/o, 2001) è un breve saggio scritto da Abraham B. Yehoshua (Gerusalemme, 1936), tra i maggiori narratori contemporanei, autore di romanzi di successo internazionale come L’amante (1977), Un divorzio tardivo (1982), Il signor Mani (1990), Ritorno dall’India (1994), Fuoco amico (2007) e Il tunnel (2018), tutti editi da Einaudi. Il saggio di Yehoshua, tradotto dall’ebraico da Alessandro Guetta e introdotto da Luca Zevi, si articola in sei capitoli ed è apparso originariamente nella raccolta Elogio della normalità. Saggi sulla Diaspora e Israele (Giuntina, 1991). Come si evince già dal titolo, il libro ruota intorno alla definizione di tre categorie: ebreo, israeliano, sionista. Nel presente contributo cercherò di illustrare, sia pure sinteticamente, la posizione assunta dall’autore su ciascuna di queste espressioni.
Consideriamo anzitutto il primo termine esaminato da Yehoshua, quello di ebreo. Chi può dirsi tale? Per la Halakhāh, la legislazione rabbinica, è ebreo chi è figlio di madre ebrea (secondo il sistema di discendenza matrilineare), oppure chi si è convertito all’ebraismo nel rispetto delle regole (è il caso dei cosiddetti “giusti convertiti”). Richiamandosi alla Legge del ritorno (5 luglio 1950), che all’indomani della nascita dello Stato di Israele (1948) ha conferito la cittadinanza israeliana a tutti gli ebrei immigrati, Yehoshua propone un’altra definizione: è ebreo colui che si identifica come tale.
Sia la definizione tradizionale che quella proposta dallo scrittore israeliano non contengono comunque alcun riferimento, esplicito o implicito, al concetto di razza. Gli ebrei non sono una razza — né si sono mai considerati tali —, bensì unicamente un popolo. Com’è noto, il concetto di razza umana è privo di validità scientifica. Gli studi di genetica hanno dimostrato da tempo che questo concetto, fondato su presunte differenze biologiche, non ha alcun valore. Le differenze fisiche più evidenti, come il colore della pelle ad esempio, sono in un certo senso quelle meno rilevanti, poiché non corrispondono a una diversità profonda del DNA; individui che discordano su pochi geni, relativi al colore della pelle o ad altri particolari somatici, possono avere in comune caratteristiche genetiche molto più complesse, anche se non visibili. L’antropologia fisica e l’evoluzionismo confermano l’inesistenza di gruppi razziali fissi o discontinui, ed è pertanto assurdo voler cercare geni responsabili di comportamenti psicologici; è impossibile categorizzare le popolazioni umane in razze, data l’alta variabilità genetica di qualsiasi carattere (mono e poligenetici; quantitativi, antropometrici ecc.).
Ma procediamo un momento per assurdo. Supponiamo pure che il concetto di razza abbia un senso (lo ripeto a scanso di equivoci: esso non ne ha alcuno se applicato alla specie umana). Ebbene, anche procedendo ab absurdo, non si potrebbe comunque parlare di una razza ebraica, e questo già solo considerando la summenzionata definizione halakhica di ebreo. Per la tradizione, un uomo che non sia figlio di madre ebrea può entrare a far parte della comunità ebraica convertendosi. Ciò dimostra chiaramente che gli ebrei non costituiscono una razza, se per razza s’intende un’entità chiusa, con determinate caratteristiche indipendenti da ogni possibilità di scelta (caratteristiche che non possono essere acquisite e rispetto alle quali non ci si può sottrarre). Al contrario, essere ebreo significa appartenere a un gruppo nazionale, a un popolo, da cui si può entrare e uscire come per ogni altro gruppo nazionale. L’affermazione dell’esistenza di una razza ebraica e l’adozione di una legislazione antisemita — pensiamo alle Leggi di Norimberga del 15 settembre 1935, emulate poco dopo da molti paesi alleati della Germania, tra cui l’Italia — rinviano a una concezione aberrante che ha presentato l’appartenenza ebraica come una sorta di prigione da cui non si può evadere (sul sedicente fondamento scientifico delle tesi razziali si veda il bel libro del biologo evoluzionista e paleontologo statunitense Stephen Jay Gould, Intelligenza e pregiudizio: le pretese scientifiche del razzismo, Editori Riuniti, 1985).
Essere ebreo è dunque per Yehoshua una questione di scelta, benché, come per ogni scelta, anche in questo caso intervengano considerazioni disparate, di carattere storico, sociale, culturale, familiare ecc. Numerosi ebrei hanno abbandonato volontariamente e definitivamente il popolo ebraico, e sono spariti per sempre nel seno di altri popoli.
Passiamo ora al concetto di sionista. Nato alla fine del diciannovesimo secolo, e finalizzato alla creazione di uno Stato ebraico in Palestina, il sionismo (da Sion, nome della collina situata a Sud-Est dell’attuale Gerusalemme) è un movimento politico piuttosto composito, caratterizzato da gradazioni diverse e spesso opposte. Ci sono sionisti laici e sionisti ortodossi, sionisti pacifisti e sionisti nazionalisti, sionisti che sostengono lo Stato di Israele da lontano e sionisti che invece ritengono loro preciso dovere contribuire direttamente allo sviluppo dello Stato diventandone cittadini. Sebbene ciascun sionista abbia una propria ideologia, in origine il comune denominatore sionista era, come detto, la fondazione di uno Stato ebraico nella terra di Israele. In un certo senso, osserva l’autore, si può dire che, una volta fondato lo Stato, il sionismo sia finito, in quanto ha esaurito il compito per il quale era sorto. Dal 1948 è perciò cambiata la definizione di sionista: questa parola è passata a indicare chi riconosce il principio per cui lo Stato d’Israele non appartiene solo ai suoi cittadini, ma all’intero popolo ebraico. È così stabilito il diritto di cittadinanza a ogni ebreo che voglia raggiungere il paese.
Il sionismo, osserva Yehoshua, non ha mai promesso di costruire una società esemplare o uno Stato perfettamente sicuro entro cui vivere; il suo obiettivo, storicamente compiuto, era tutto sommato meno ambizioso: fondare uno Stato ebraico nella terra di Israele, e fare in modo che in questo Stato ogni ebreo potesse trovare la sua casa. Bisogna riconoscere che la nascita dello Stato di Israele nel 1948 ha rappresentato un episodio saliente della storia ebraica moderna ed è stato l’esito, tutt’altro che scontato, di un iter plurimillenario e spesso tragico.
Questo di Yehoshua è un libro di definizioni. Definire, compito che alcuni evitano accuratamente (non solo perché si tratta di un esercizio oneroso, ma altresì per il timore di restare imbrigliati nella definizione formulata), permette, sia pure entro certi limiti, di arrivare al nocciolo dell’argomento trattato dissipando eventuali equivoci. A proposito di equivoci possibili (e ahimè ricorrenti), Yehoshua mette in guardia il lettore: come non è il caso di confondere le espressioni Stato di Israele e Terra di Israele (la prima rappresenta un concetto politico dai contorni precisi, la seconda è una nozione geografica piuttosto vaga), così non vanno sovrapposti i termini antisionismo e antisemitismo. Un antisionista non è ipso facto un antisemita. Si tratta di concetti ben distinti, e tali devono restare. Yehoshua fa inoltre una considerazione, che si può condividere o meno, ma sulla quale sarebbe il caso di riflettere:
“La strategia adottata dallo Stato di Israele di considerare ogni antisionista come antisemita non farà diminuire il numero degli antisionisti, ma farà crescere il numero degli antisemiti” (p. 53).
La terza categoria — israeliano — ci riporta agli albori della civiltà ebraica. Il popolo ebraico è il popolo di Israele. Gli Israeliti si riconoscevano discendenti da un capostipite comune, chiamato appunto Israele. Questo capostipite, guida delle dodici tribù che in tempi storici costituiscono il popolo israelitico, è chiamato originariamente Giacobbe nei racconti della Genesi che ne narrano l’origine e le vicende, fino al momento in cui il suo nome viene cambiato in quello di Israele. Figlio di Isacco e Rebecca e nipote di Abramo, Giacobbe è il terzo patriarca biblico. L’epiteto Israele, la cui etimologia è ancora dibattuta dagli studiosi, rimanda probabilmente alle circostanze narrate in Genesi [XXXII, 25 - 33], che qui rievoco brevemente. Una notte Giacobbe, di ritorno dal volontario esilio nell’aramaica Ḥarrān, accampatosi presso il fiume Yabboq, di là dal Giordano, lottò a lungo con uno sconosciuto (un angelo inviato dal Signore), il quale, non riuscendo a batterlo, lo colpì all’anca rendendolo claudicante. Stanco di lottare, l’angelo chiese al suo avversario di lasciarlo andare, poiché l’alba era ormai vicina; ma Giacobbe rifiutò di farlo se prima quegli non lo avesse benedetto. L’altro accettò e gli impose un nuovo nome: Israele.
“Il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele; ché se fosti forte lottando con Dio, quanto più avrai vittoria lottando con gli uomini? (Gen. 32,29)”.
È opinione diffusa tra gli studiosi — anche se non unanimemente condivisa — che la parola Yisra’el alluda alla teomachia descritta nella Genesi e significhi perciò perseverare con Dio, nel senso della perseveranza nella lotta (dalla radice shr, lottare) che Giacobbe ingaggiò con l’angelo del Signore (El).
Ebreo e israeliano — avverte Yehoshua — non sono meri sinonimi come certuni tendono a credere. Ebreo è termine legato alla fede religiosa del popolo di Israele (sebbene la religione esprima solo una parte, indubbiamente rilevante, dell’essenza e del comportamento del popolo ebraico) e al tempo della diaspora (termine che designa la dispersione degli ebrei nel mondo dopo l’abbandono coatto della sede di origine); israeliano indica invece l’ebreo — religioso o laico che sia — il quale conduce un’esistenza ebraica “completa”, i cui tratti distintivi sono la terra, la lingua e un contesto sociale autonomo.
L’attenzione di Yehoshua si concentra anzitutto sulla “parzialità” della vita dell’ebreo nella diaspora. Bisogna intendersi qui sul significato degli aggettivi completo e parziale per non equivocare le osservazioni dell’autore. Nella diaspora il contesto politico, sociale, economico, militare, culturale e linguistico cui l’ebreo è inserito non era ebraico. L’ebreo partecipava, in misura maggiore o minore, a seconda dei casi, alla vita del popolo in mezzo al quale si trovava; al contempo, era costretto a limitare il suo ebraismo alle ore serali oppure ai giorni di festa, e a esprimerlo nella cerchia più o meno ristretta dei suoi contatti familiari e sociali. La parzialità dell’ebreo nella diaspora non riguardava ovviamente l’intensità dei suoi sentimenti né la rettitudine della sua coscienza. Sotto questi aspetti un ebreo poteva tranquillamente essere — e spesso lo era — un uomo completo, esemplare. La parzialità riguardava piuttosto la realtà esteriore: una realtà che risultava necessariamente condizionata e difettosa. Riassumendo: per Yehoshua il termine ebreo si addice alla situazione esistenziale della diaspora e sta a indicare una realtà parziale che può solo avere l’apparenza della totalità; ebreo e israeliano stanno tra loro come una parte sta al tutto.
Sul tema della diaspora — che Yehoshua, per ovvie ragioni, sfiora appena nel suo saggio — ci sarebbe molto da dire. Non è ovviamente questa la sede più adatta per sviluppare una riflessione su un tema così articolato. Del resto, chi voglia approfondire l’argomento, può contare su una bibliografia piuttosto ampia. In questa recensione faccio notare soltanto un aspetto: nella sua introduzione Luca Zevi, pur concordando con Yehoshua su molti punti, avanza nel merito un’interpretazione che diverge in parte dal giudizio formulato dallo scrittore israeliano. Laddove Yehoshua ridimensiona la portata storica della missione morale e religiosa dell’ebreo errante (e con essa l’idea che Dio sia stato giusto nel disperdere il suo popolo tra le nazioni), Zevi sostiene che è anche grazie alle peregrinazioni degli ebrei che si sono diffuse, in Europa e nel mondo, nuove forme di identità caratterizzate dal plurilinguismo, da una maggiore mobilità, dall’apertura al confronto e da una spiccata creatività.
Nel riferirsi alla categoria di israeliano, Yehoshua parla di esistenza ebraica “completa”. Cosa significa in concreto l’aggettivo messo tra virgolette? Per rispondere a questo interrogativo, trascrivo una riflessione dell’autore che ritengo decisamente eloquente. Si tratta di un ragionamento che, da un lato, fa appello al sistema di valori e al senso di responsabilità di ciascun israeliano e, dall’altro, guarda direttamente al futuro:
“Essere israeliani significa essere ebrei totali, e questa totalità della vita stessa è ciò che produce la nostra responsabilità ebraica. La responsabilità ebraica dell’ebreo nella diaspora è estremamente limitata. In un senso egli rimane un ebreo “pulito”, perché non è come ebreo che ha responsabilità di politica estera per il paese in cui vive, o responsabilità militari, o per le carceri, o per le differenze sociali, o per la corruzione del potere ecc. Se ne sta con i suoi libri che racchiudono una quantità di valori, e solo una piccola parte di essi è coinvolta nella vita reale e si sottopone al suo esame. In Israele ogni particolare dell’esistenza è sottoposto alla prova dei valori, delle credenze, del comportamento e dei sogni ebraici. E chi si preoccupa della coerenza di questi valori deve metterli in pratica, e non farli rimanere nella teoria. Un carcere israeliano è condotto secondo principi ebraici? Ecco una domanda concreta. Quando i soldati israeliani osservano la “purezza delle armi”, i valori ebraici ne escono rafforzati, mentre quando fanno qualcosa di ingiusto, i valori ebraici vacillano. Non c’è più la distinzione tra un mondo spirituale chiuso, in cui si dibatte sulle idee, e una realtà per la quale tutto ciò è irrilevante. Buona parte della nostra eredità spirituale funzionava solo in teoria, e ciò che vi è di doloroso e di affascinante nella realtà israeliana è la messa a nudo della teoria alle prese con la vita” (pp. 71 - 72).
In questo saggio chiaro e conciso, la cui lettura raccomando vivamente (si tratta oltretutto di una lettura rapida: il testo supera appena le ottanta pagine), Yehoshua ci guida nella comprensione di tre parole che ricorrono spesso nel dibattito attuale, sia pubblico che privato, ma che sono a volte travisate — in buona o mala fede — e utilizzate con deplorevole superficialità. In un’epoca di tensioni e mai sopiti rancori come la nostra, in Ebreo, israeliano, sionista: concetti da precisare Yehoshua affronta, con lucidità e spirito critico, alcuni temi nodali della cultura ebraica e della storia contemporanea.