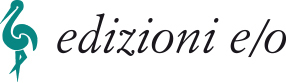Il legame tra Viola Di Grado e la moda, fil rouge di questo numero di To Be, è un rapporto tutt'altro che celebrativo. A partire dal suo romanzo d'esordio, il pluvi premiato e chiacchieratissimo 70 acrilico 30 lana (2011, Edizioni e/o), che già dal titolo focalizza l'attenzione su una proporzione tessile che ha un'esigua composizione naturale c una spiccata prevalenza di sintetico, fino a] look di ispirazione gotica della giovane scrittrice: le labbra spesso truccate di nero, i lunghi capelli sciolti con scriminatura centrale, abiti da bambola e accessori' vistosi, a crearne un'immagine quantomeno eccentrica. Il padre è Antonio Di Grado, ordinario di letteratura italiana all'Università di Catania e grande studioso di Sciascia e De Roberto, la madre è la giornalista e scrittrice Elvira Seminara. Cresciuta in un clima di grande fertilità culturale e di amore per le lettere, Viola ha scritto il suo primo racconto a 5 anni e al momento si sta specializzando - dopo una laurea in lingue orientali - in filosofia cinese a Londra. Le motivazioni al Premio Campiello Opera Prima assegnatole a fine maggio di quest'anno, recitano: «Si capisce che il romanzo è di una spiccata originalità ed è contemporaneamente racconto di una non comune crudeltà». Ed è proprio una sottesa crudeltà quella che guida la trama e la forma di 70 acrilico 30 lana attraverso un'operazione distruttiva preliminare che coinvolge tanto l'azione quanto il linguaggio. Non si tratta di una storia d'amore, come è chiarito programmaticamente sin dalle prime pagine; «anche se vorrebbe tanto esserlo, darebbe dieci paragrafi per esserlo», ma di una vicenda di dolore e inadeguatezza ambientata a Leeds, «dove l'inverno è cominciato così da tanto tempo che nessuno è abbastanza vecchio da aver visto cosa c'era prima». Un clima metaforicamente perfetto per accompagnare la vita di Camelia, italiana trapiantata nel Regno Unito, sprofondata in un tunnel di non senso e autolesionismo da quando il padre, in compagnia dell'amante, è finito fuoristrada ed è morto. Quel fosso, buco nel terreno divenuto sepolcro, si trasforma in una nuova unità di misura per la madre di Camelia, che smette di parlare e fotografa ossessivamente buchi: nelle tende, nel divano, nei vestiti, nel formaggio. E se Camelia inizialmente ne asseconda e imita l'afasia, imparando a (non) comunicare con il (non) linguaggio degli sguardi, torna poi alla parola con impeto quasi bulimico. Camelia che recide i fiori, che recupera vestiti dai cassonetti e li violenta con tagli e stralci di stoffa estranei e incompatibili, che si innamora del suo maestro di cinese Wen e degli ideogrammi che lui le insegna, che traduce manuali di utilizzo per lavatrici e vomita parole sui marciapiedi. Viola Di Grado ha costruito un romanzo di eccezionale maturità, in cui i gesti e le parole dei personaggi (là dove le parole riescono faticosamente a sopravvivere senza sprofondare, anch'esse, in uno dei tanti buchi del racconto) si susseguono con una consapevolezza a dir poco spiazzante. L'intero libro sembra una battaglia contro i luoghi comuni, le convenzioni, le convinzioni radicate e inutili. Bersagli di questo tiro a segno sono l'illusoria facilità della comunicazione di massa, la bellezza ostentata e, manco a dirlo, la moda. Tanto che, se le si chiede di dare una definizione della moda, risponde "carneficina". Di tutti i simboli che permeano 70 acrilico 30 lana abbiamo a provato a chiedere qualche chiarimento. A partire dalla città di Leeds, dove la Di Grado ha realmente vissuto durante un Erasmus...
Com'è in realtà Leeds?
«Leeds è estrema e ambigua, anche se a me è piaciuta molto».
La protagonista si chiama Camelia, che nel linguaggio dei fiori significa "superiorità non esibita". È un caso?
«Ho scelto quel nome perché quando la pianta della camelia muore, cade l'intero fiore, come decapitato. Io i fiori non riesco a curarli, dimentico di innaffiarli e loro per vendetta appassiscono. Mi viene in mente un bellissimo verso di Sylvia Plath che dice
- se ricordo bene - "Ma sarò utile quando sarò distesa per sempre. Forse allora gli alberi mi toccheranno e i fiori avranno tempo per me"».
C'è un buco in cui cade e muore il padre di Camelia, ci sono i buchi che fotografa sua madre ...
«La mia storia nasce da un buco, da un'assenza di significati, da un lutto che ha annullato il senso delle parole e del tempo. A me i buchi piacciono molto, le caverne ad esempio. Nell'immaginario cinese taoista, le caverne sono luoghi di rivelazioni: vi si trovano testi sacri che raccontano i significati segreti del cosmo».
Ha lavorato molto sulla ricerca linguistica?
«Sono affascinata dal linguaggio verbale. Volevo che nel mio libro fosse tutto linguaggio. La mia ricerca parte da una riflessione sulla natura morfosillabica del cinese e su certe idee della filosofia cinese. Penso al "dimenticare il linguaggio" di cui ha parlato Zhuangzi: usar lo senza cadere nelle "trappole per pesci" delle associazioni, convenzioni che le parole si portano dietro. Quindi, per me, lavorare sul linguaggio vuoi dire distruggerlo come fa Camelia coi vestiti, e poi reinventarlo».
Perché Camelia recupera e distrugge abiti?
«Per ribellione alla possibilità che si possa condividere un'identità di qualsiasi tipo: la moda alimenta quest'illusione». È vero che lei raccoglie oggetti per strada e ne fa collane? «SÌ, sono altruista verso gli oggetti perduti».
Se dico "moda", risponde ...
«Carneficina».
Essere felici è come ...
«Come in questo verso di Bjork "I stand by the ocean, make it roar at me, and I roar back." (''Guardo all'oceano, lascio che urli contro di me, e gli rispondo urlando", tratto da Violently Happy, n.d.r.)».
E lei è felice?
«Felicissima e tristissima. Quando scrivo le due condizioni coincidono perfettamente, come gli estremi in un cerchio».
- Home
- Recensioni
- Viola Di Grado: La moda? Una carneficina.