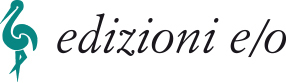“Are you sure this country does exist?” chiede il funzionario statunitense quando nel 1992 l’allora sessantatreenne Christa Wolf esibisce orgogliosamente alla dogana il suo vecchio (e ancora valido) passaporto. La Ddr non esiste più da due anni, liquidata come ‘una postilla della storia’, se non come ‘stato illegale’ , per usare formule allora correnti nella stampa occidentale. La scrittrice, che con Trame d’infanzia e ancor più con Cassandra ha conquistato il pubblico americano, è ospite del prestigioso Getty Center di Los Angeles, quasi una fuga dalle rovine del socialismo reale – e raccoglie materiale per la sua Medea. Ma intanto si guarda intorno, la California la sollecita con la sua eterogeneità etnica, le contraddizioni di un capitalismo avanzato, il divario tra i bianchi, i neri e i latinos. Accumula quaderni di appunti: li riprenderà in mano a più riprese fino all’anno della redazione finale, il 2007, assemblando un testo autobiografico, se pur intessuto di elementi d’invenzione e del brusio onirico caratteristico del romanzo del Novecento. Chi racconta è “un io consanguineo” – come dice la stessa Wolf - che talora decolla nel “tu” di remote vicende: una tecnica già adottata in altri testi ma che qui consente sia di limitare l’assolo caratteristico dell’impianto autobiografico, sia di coinvolgere con il tu lo stesso lettore, invitandolo a mettersi per così dire in parallelo rispetto all’introspezione del romanzo.
Al centro c’è la storia di un’intellettuale comunista tedesca, con le sue ragioni e le sue sconfitte. In questo senso: un libro europeo. Ha ragione Hannes Krauss a sostenere, nell’articolo qui accanto, che l’esperienza statunitense è stata determinante. Perché la riflessione a tutto campo sulla propria identità politica nasce da un continuo contrappunto con quel nuovo mondo, così diverso e per molti aspetti così disarmante con l’apparente ingenuità ideologica del “take it easy”. Un confronto da cui scaturisce talora anche una certa vis comica, ancorata al piccolo quotidiano, già felicemente emersa nei racconti americani del 2005 e qui finemente ripresa dal duttile registro di Anita Raja.
L’andamento diaristico è organizzato secondo una doppia prospettiva - all’esperienza statunitense si sovrappone lo sguardo successivo, fino alla crisi finanziaria dei nostri giorni. Ma arretra nel tempo tedesco fin dalle prime pagine, la Wolf. Ha nella valigia delle lettere che le “ustionano l’anima”, il carteggio di Lily, una comunista emigrata in America– della quale si prefigge di ricostruire l’esistenza. E’ il filo narrativo che apre con una seconda voce su due fronti del passato, quello dell’antifascismo e quello inedito, o meglio rimosso ma appunto ustionante, delle persecuzioni staliniane.
Sul primo fronte Wolf ricorre alla grande letteratura, meditando le vicende di scrittori in fuga dal nazismo. Sfilano Döblin, Brecht, Feuchtwanger, Werfel e i fratelli Mann, tutti approdati in California. Un devoto pellegrinaggio, denso di excursus collaterali, conduce il lettore lungo la costa del Pacifico ombreggiata di palme attraverso le residenze di quegli intellettuali tedeschi che, “New Weimar” negli anni oscuri del nazismo, animavano Santa Monica, fino alla maestosa villa nascosta nel verde in cui venne alla luce il Doktor Faustus. Tra le pagine più intense e immediate del testo c’è la visita a una vecchia libreria antiquaria alla ricerca di scritti sull’esilio. Wolf si arrampica accaldata su per una scaletta di legno e dai mucchi di riviste e volumi ingialliti, accatastati dall’anziano libraio ebreo, affiorano da Heine a Remarque, fino ai testi bruciati nei roghi hitleriani, le voci della sua formazione. Sono i gioielli di famiglia della sua appartenenza ideologica, volti noti che rimandano a incontri lontani. E scende dagli scaffali una teoria di intellettuali tedeschi oggi dimenticati, figure sepolte dal nuovo mercato, ombre scomparse di resistenti, ebrei riparati in America che pur sempre – si legge tra le chiose a matita in un libro – “amano la Germania e ne hanno nostalgia”. Autori in parte dispersi, testimoni dello sradicamento, anche linguistico dell’esule. La Wolf traccia qui una mappa, quasi un atto di consegna a futura memoria: un affondo in quella letteratura dell’esilio destinata dopo la guerra, sottolinea con orgoglio la scrittrice, a un’ampia ricezione nella Ddr, “legittima erede di quella Germania perseguitata”.
I libri collegano le generazioni e il cerchio del passato si chiude sul presente. Sono i figli delle vittime, ebrei di seconda e terza generazione a parlare nella Città degli angeli. Il sistema dei personaggi adottato nel romanzo mette bene in luce la calda accoglienza americana ma anche l’iniziale difficoltà d’incontro tra la Wolf – tedesca - e i superstiti del massacro. Certo, lei è la celebre scrittrice e i suoi interlocutori sono intellettuali, femministe, teste d’uovo del Getty Center. Gente democratica, che ne apprezza l’arte e l’impegno etico. Ma Wolf viene pur sempre da quel paese “che ha gettato i bambini nelle fiamme come farfalle in volo” - le ricorda una sopravvissuta con un verso di Nelly Sachs. E Wolf non lo dimentica. Questo dell’impatto diretto di un autore tedesco con il linguaggio e lo sguardo dei “survivors” di oggi è nuovo nella letteratura contemporanea. Sono pagine di ascolto ma anche di analisi psicologica dei diversi esiti del lutto nella “second generation”. La scrittura si fa vigile e paziente. Attraverso lo schermo iniziale della lingua inglese – tana di adozione delle vittime rispetto al tedesco dell’origine, contaminato dal carnefice – filtra il diagramma delle variegate posizioni degli ebrei oggi statunitensi, dal rifiuto totale nei confronti della Germania all’interesse dei più giovani per il paese riunificato.
Va osservato che nell’economia del romanzo i personaggi di origine ebraica costituiscono la maggioranza. Sono loro gli interlocutori privilegiati della Wolf, a cominciare da Peter Gutman – nomen omen - vero e proprio angelo tutelare, nonché snodo del secondo fronte del romanzo, quello dell’anamnesi di una fede comunista. Il dato scatenante non è solo la scomparsa della Ddr che la Wolf ha vissuto con amarezza – fino al collasso psichico, come sappiamo da Quel che resta. E’ anche il bombardamento mediatico che nel 1992 segue all’apertura degli archivi della Stasi. Non si sofferma la stampa occidentale sui 42 volumi di rapporti segreti sulla coppia Wolf, sorvegliata fin dal 1976. Ben più ghiotte, anche perché firmate con uno pseudonimo, appaiono ora le relazioni sui dibattiti letterari redatte dalla giovane Christa, appena trentenne, in veste di funzionaria della Lega degli Scrittori. Investita in America dal malodore della Stasi, la Wolf è sgomenta. Potrebbe difendersi richiamando la tensione degli anni Cinquanta e il pericolo della destra revanscista in una Ddr non ancora barricata dietro il muro. Non lo fa – e forse oggi non verrebbe capita. Sceglie la strada dell’introspezione a tutto campo, “rovesciando il mantello di Freud” per scavarsi dentro fino allo stremo (talvolta anche del lettore). Gutman, il filosofo di formazione francofortese che ha perso i nonni a Theresienstadt, ne diventa il confidente. E’ uomo di liberi occhi e pensieri che con l’autrice condivide una familiarità con l’intellighentia russa. Sa essere giocoso e affettuosamente ironico lui, il “Monsieur”, nello spronare tra un drink e l’altro “Madame” a scrivere, a rivendicare la propria storia. La memoria riattraversa allora l’infanzia e la vediamo Christa bambina negli anni hitleriani in cui “comunista” ed “ebreo” erano un insulto. Poi, dopo l’epidemia di tifo del 1945 calva e sperduta, cercare riparo nel marxismo, aderendovi toto corde. Tanto che quando nel ’53 gli operai in rivolta gettano i distintivi di partito, lei no – nessuna incertezza, perchè (brechtianamente) è sicura di essere “in possesso della verità” fino a raccattarli da terra quei distintivi. L’autoritratto non manca di ironia: arrestata come agitprop a Berlino Ovest, in carcere chiede Marx – sarà invece servita dal “ nemico di classe con riassunti di Shakespeare”. Procede a lampi di stampatello, e sogni, e domande la narrazione - ma con un basso continuo, la colpa nazista nei confronti dei russi. E la consapevolezza dei vecchi antifascisti che nel dopoguerra una Ddr poteva sopravvivere solo all’interno del blocco sovietico. Non a caso la Wolf richiama alla memoria la condanna a morte dei Rosenberg, i coniugi comunisti accusati di spionaggio a favore dell’Urss nell’America di McCarthy. Un motivo di fondo, questo della necessità esistenziale di una zolla tedesca comunista su cui approdare, che si articola attraverso altre voci di anziani compagni evocati a testimonianza, come Louis Fürnberg, poeta ebreo praghese scampato al processo Slansky che nel 1954 a Weimar, nell’ombra del Goethe-Schiller-Archiv, troverà salvezza. Qui s’incunea, nel ricordo della Wolf, il perno di quella tacita rimozione dello stalinismo che investirà anche parte della sinistra europea. Il silenzio sul terrore come prezzo della Heimat Ddr.