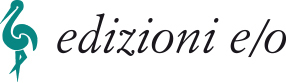L'elemento più notevole in Cuore cavo, secondo romanzo di Viola Di Grado (venticinque anni, un fortunato esordio nel 2011 con Settanta acrilico, trenta lana) è la tensione perfettamente gestita tra un immaginario tutto improntato al più sontuoso barocco mortuario, e uno stile svelto, scorciato, senza snodature sintattiche e forzature semantiche evidenti. Semmai una serie di continui, sottili smottamenti anaforici che decompongono impercettibilmente il significato più consueto dei termini, come in questo agile passaggio: «Si mettono la crema sul corpo e il cuore in pace», dove un gran numero di immagini, pensieri, giudizi e implicazioni emotive sono presi insieme in un breve giro di alta densità aforistica. Capita spesso con gli scrittori siciliani, più magri che grassi (Lampedusa a parte, inventore della dicotomia), disseccati nella forma quanto più torbidi e sensuosi nella sostanza. «Io m'aspetto sempre che tu dia fuoco alle polveri, le polveri tragiche-barocco-grottesche che tu hai accumulato. E questo potrà difficilmente prodursi senza una esplosione formale, della tua levigatezza compositiva», scrisse una volta a Sciascia Italo Calvino. Sciascia non seguì mai il consiglio. E alla secchezza si attiene anche Viola Di Grado, come chi voglia appunto non far esplodere ma contenere, raffreddare, araldicamente incastonare un eccesso.
Mortuario, decompongono e raffreddare non sono espressioni scelte a caso; discendono dal tema. Cuore cavo è il racconto di una morta, Dorotea Giglio, venticinquenne suicida per taglio delle vene il 23 luglio 2011; ed è il racconto di cosa accade non prima - salvo qualche flashback - ma dopo la sua morte. Il romanzo si apre nella speranza che con sé finisca anche il mondo: «Una brezza leggera si è alzata come un sollievo, e la mia morte, solitaria e profonda, ha lasciato l'isola. Da quel giorno, in silenzio, ha contagiato il resto del pianeta, lenta come lo smog, solenne come un vuoto, privata come una preghiera, diventando presto uno dei fenomeni ambientali più urgenti e più invisibili». Ma non è così che funziona. Il mondo sopravvive. E anche chi è morto non cessa di sentire né di soffrire. Si sdoppia in un corpo che si decompone - processo le cui fasi Dorotea, ex studentessa di biologia, descrive con uno strano misto di tenerezza e di meticolosità nomenclatori da coroner - e in un animo che continua indisturbato a frequentare i luogohi e le persone di prima: la madre depressa, la zia Clara, legate dal lutto per la terza sorella, Lidia, altra suicida. L'ex fidanzato, il negozio di cartoleria dove lavorava da viva, una Catania afosa e livida ma tollerante nei confronti delle schiere di morti che la percorrono. Dorotea non è un'eccezione, i morti si cercano, si frequentano tra loro. Scrive, riflette, si innamora, prende l'aereo e va a Londra con l'amica più cara a sentire un concerto di Amy Winehouse, morta anche lei il 23 luglio 2011, una scena bellissima. I vivi però non possono in genere né vederla né toccarla, e questo è il contrappasso più crudele per chi si è ucciso sentendosi ignorata, in vita, dalla madre e da tutti. Tra vita e morte non c'è differenza, solo un giro di vite di tristezza, il rimpianto per qualcosa che non era da rimpiangere, l'alternativa tra lo spreco e l'inutile.
Senza più i vincoli del corpo, i morti soffrono di un eccesso di libertà in cui il tutto coincide con il nulla. «La realtà era una belva estinta, e potevo darle i nomi che volevo. Ma i nomi servivano a poco, senza più i sensi per chiamarla a me». Singolare sovrapposizione tra una tematica di marca schiettamente adolescenziale (nichilismo, narcisismo, autolesionismo, il tutto elevato a dimensioni cosmiche) e un'acuta consapevolezza della natura della finzione letteraria. Ammirevole e raggelante.
Cuore cavo si legge con stupore, non con abbandono, e non per qualche difetto ma per un trionfo di fattura. A me ha ricordato la crudeltà che il giovanissimo Flaubert esercita su se stesso nelle Memorie di un pazzo: rigore d'artista e rigor mortis, la sfida accettata della monotonia, l'introspezione come necrofilia, la maledizione su ogni forma di vita che non diventa scrittura.
Gli scrittori che non credono nella vita sono obbligati a essere perfetti: o dar fuoco alle polveri, o ricoprire la polvere con l'oro dello stile, rinunciando al calore. Viola Di Grado, che per designare l'insorgere di una speranza pesca splendidamente un termine come «imboscata», lo sa fin troppo bene, e corre con coraggio il proprio rischio. Per scelta, forse; o più probabilmente per vocazione.
- Home
- Recensioni
- Un concerto di Amy Winehouse risuona nel mondo segreto dei morti