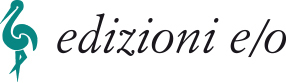Nel corso della propria esistenza, l’uomo incappa incessantemente in domande senza risposta, in questioni irrisolte che trovano il loro degno coronamento solamente alla fine del proprio percorso materialistico-corporeo.
Cosa rappresenta la morte e perché ci spaventa così tanto? Perché rimaniamo attaccati all’ultimo baluardo di speranza, all’ultimo soffio di vita quando tutto sembra perduto? E ancora. Quali angosce esorcizziamo quotidianamente scacciandole dai nostri pensieri?
Charles Bukowski ne “ Il capitano è fuori a pranzo” scriveva: “ Nella morte non c’è niente di triste, non più di quanto ce ne sia nello sbocciare di un fiore. La cosa terribile non è la morte, ma le vite che la gente vive o non vive fino alla morte”.
Si può più o meno dissentire sul pensiero di uno degli scrittori maledetti per eccellenza, ma è un dato di fatto che in ogni epoca, in ogni momento storico, l’uomo sia messo di fronte a sé stesso, insediato dai dubbi e da domande esistenziali di vario tipo, domande sul senso della vita, della morte e su ciò che accade dopo quel al di là che molti hanno l’ardire di definire oltretomba (poiché è molto di più di un oltretomba).
Non si esime dall’interrogarsi su tutto questo nemmeno Viola Di Grado che, con il suo “Cuore cavo” edizioni e/o, bissa il successo del suo primo romanzo “Settanta acrilico trenta lana”.
La giovane scrittrice siciliana, mirabile esempio della cultura italiana, si addentra in un territorio oscuro e affronta con minuziosa quasi chirurgica perizia il tema assai scabroso, almeno per l’Occidente, del cosiddetto trapasso e lo fa senza pietismi in modo quasi crudo e brutale, privo di fittizie trame consolatorie.
Dorotea, la protagonista del romanzo, si suicida per troppa sete di vivere, il suo paradosso estremo lo sperimenta su sé stessa e sul suo cadavere in lenta ed inesorabile decomposizione.
L’autrice descrive minuziosamente il disfacimento del corpo di Dorotea la quale ripercorre quotidianamente i propri traumi attraverso una compenetrazione di presenze; la madre, la zia morta, gli affetti un tempo a lei cari e il suo piccolo mondo fatto di piccole cose.
Spirito, fantasma o anima assorta, comunque la si chiami, la protagonista è un essere che non si arrende allo stato delle cose e che troverà finalmente la sua quiete dopo un lungo percorso di peregrinazione interiore.
Viola Di Grado nonostante la crudezza del racconto ci regala pagine intensamente liriche e vibranti sospese fra echi e rimandi alla Spoon River di Edgar Lee Masters e alle atmosfere gotiche dei romanzi ottocenteschi, ma anche alle filosofie orientali e al buddismo in un mistico e surreale inno alla vita.
Dorotea sperimenta su se stessa l’eccesso di libertà portato dalla morte in un senso di onnipotenza irreale che la conduce in un delirio onirico alla ricerca della verità; la verità sulla morte della zia, sulla relazione con l’ ex ragazzo, sul perché le contingenze dell’ esistenza ultraterrena la trascinino in un vortice di traumatiche esperienze senza fine.
Ma quella che noi chiamiamo fine non è forse l’inizio di qualcosa di nuovo? Viola Di Grado, attraverso le vicende della protagonista, sembra ricordarci che tutto non si esaurisce con il solo disfacimento materiale del corpo, ma che l’anima, lo spirito o qualsivoglia forma di eterea sembianza, continua ad esistere nel prolungamento dell’ attesa, nella metamorfosi di un altrove dai contorni irreali.
Nel suo viaggio verso un’assenza presente, Dorotea si accompagnerà a creature tormentate come lei, raccolte nella meditabonda nostalgia delle cose; “Nostalgia di quando la speranza aveva un senso logico, proiettata com’era sul futuro: ora invece cammina all’ indietro come un gambero […..] Ho nostalgia, più di tutto, della nostalgia: ricordare il passato non è più struggente né romantico”.
La protagonista riflette sul senso della sua morte e della morte in generale “Ma cosa ne avrei fatto di quella morte? Davvero era per me una cosa così importante? Quello di cui blaterava tutta l’arte dai tempi remoti, io adesso lo stavo vivendo. Sentivo un enorme e scomoda responsabilità. Avere un corpo mi dava il privilegio di un punto di vista limitato, di essere irresponsabile verso la vastità e la portata mistica dell’ Universo. Adesso invece, tutt’ a un tratto, mi ritrovavo cittadina dell’ Assoluto, con tutta la serietà che richiedeva. Adesso il Tao e il Nirvana erano questioni di ordinaria amministrazione. Adesso il ponte zoroastriano dell’ Aldilà non mi riguardava meno di quello sullo stretto di Messina. [….] Mi guardai: vista da fuori non mi somigliavo per niente”.
Viola Di Grado, attraverso la propria protagonista, prende a prestito la morte per riflettere ampiamente sull’ umanità e perfino sull’ etimologia di certe parole; “Pensai ad altre parole con il prefisso “sopra” e mi resi conto che si trovavano tutte al di sopra di me. Sopravvalutare, sopraggiungere, soprannaturale. Non sopravvaluto più, ora che ho vistoli peggio. Non sopraggiungo più, perché sono sempre assente. Non concepisco più il soprannaturale, perché non c’è niente di più soprannaturale di me. Il prefisso “sopra” indica il superamento di un limite, e io non ho superato nessun limite: sono la prova che la morte non lo è. Io non sopravvivo, sottovivo.”.
La poeticità del racconto della giovane autrice siciliana, intessuto di sottili ragnatele psicologiche, si fa pragmatica riflessione sull’ avvenire, sul nostro destino, su quello che coviamo dentro di noi, sugli affetti profondi e sul superamento del materialismo, così come recita la religione orientale ( ma infondo anche quella occidentale).
Come afferma la stessa Viola Di Grado “Non credo nella morte. Come dicono i Taoisti si tratta solo di un cambiamento. M’interessava raccontare la morte come una vita che cambia modalità d’interazione: Dorotea muore ma è più viva nel romanzo, la sua sensibilità si muove semplicemente in un altro senso, è testimone della vita senza il privilegio o limitazione di starne a contatto, di toccarla. L’amore diventa una forza che non ha bisogno di essere confermata o ricambiata, agisce per sé come forza di gravità. Lei è come una dea, una mistica la cui materia ha superato il corpo”.
Tutti partono, tutti se ne vanno, tutti immancabilmente ritornano in un percorso di ascesa e di elevazione verso l’infinito. In fondo, come diceva Gabriele D’Annunzio, non è forse vero che “Siamo spiriti azzurri e stelle”?
- Home
- Recensioni
- Il senso di Viola per l'aldilà