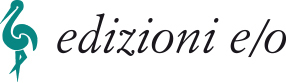Il numero di somali in fuga dal conflitto tra il governo spalleggiato dall’Etiopia e una coalizione di gruppi armati ribelli ha superato il milione. Lo riferisce l'ONU. Solo nelle ultime due settimane 200.000 persone hanno lasciato Mogadiscio e si sono ammassate in campi provvisori.
«Se questo stesse accadendo in Darfur si solleverebbe un gran clamore», ha dichiarato al New York Times Erich Laroche, capo delle operazioni umanitarie ONU in Somalia. Le Nazioni Unite hanno organizzato veri e propri tour di giornalisti, affinché si parli di quella che, secondo un altro dirigente del Palazzo di Vetro, è «la peggiore situazione di tutto il continente africano».
Che al fine di ottenere attenzione Laroche e i suoi colleghi scatenino una competizione per ‘la tragedia più tragica’, la dice lunga sulla debolezza dell’ONU nelle crisi umanitarie.
Una debolezza che forse ha origine proprio in Somalia. Il 3 ottobre del 1993 il tentativo di catturare alcuni luogotenenti del signore della guerra Aidid si concluse in un disastro. Nel giro di poche ore morirono quasi un migliaio di somali e, soprattutto, diciotto soldati statunitensi. Da quel giorno gli USA e le altre potenze iniziarono a smarcarsi dalle missioni di pace dell’ONU e il primo paese a farne le spese fu il Rwanda.
Mentre le televisioni mostravano il cadavere di un ranger americano trascinato per le strade di Mogadiscio, nel paese delle mille colline emergevano le prime prove della pianificazione di un massacro. Ma i dirigenti dell’ONU e i diplomatici di paesi come Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna non vollero rischiare propri soldati per fermare una carneficina di africani.
Così, chi aveva preparato il genocidio potè agire indisturbato. Esther Mujawayo, vittima designata in quanto tutsi, si salvò ma perse duecentosettantaquattro parenti tra cui suo marito e sua sorella Stephanie. Nel 2005 è tornata in Rwanda insieme alla giornalista algerina Souâd Belhaddad. Voleva trovare i corpi di sua sorella e dei suoi nipoti, il resto non le interessava molto. «Non cercavo né vendetta né giustizia, e neppure un colpevole; cercavo un bambino».
Ma la ricerca di informazioni l’ha spinta eccome a fare i conti con la giustizia e i colpevoli. In Rwanda avevano appena iniziato a funzionare i gacaca, tribunali tradizionali attivati per smaltire oltre centomila processi. «Sinceramente, lo confesso, non riuscivo a capire come questo tipo di giustizia potesse adattarsi a un contesto come quello del genocidio. Sai, agli occhi di un sopravvissuto nessuna giustizia potrà mai sembrare adeguata».
Ma, appreso che per ottenere la riduzione della pena spesso gli imputati confessano le loro colpe, Esther ha partecipato al gacaca nel villaggio di sua sorella, sperando di scoprire in quale fossa è stata gettata.
Il fiore di Stephanie racconta il viaggio di Esther e Souâd tra assassini, vigliacchi, bugiardi; tra giovani sopravvissuti che non riescono a studiare, tra donne scampate al massacro che lavorano nei campi di rieducazione per i genocidari, come Théophila: «Magari se ne pentirà solo uno su sessanta, magari solo uno accetterà di ricostruire una vita insieme, ma è già qualcosa; sarà comunque una persona salva, perché noi sopravvissuti non vogliamo uccidere, non vogliamo vendicarci, vogliamo ricostruire. Ho la morte dentro, ma vado avanti».
L’Occidente, nel racconto di Esther - che oggi vive a Dusseldorf dove lavora come sociologa e psicoterapeuta - è quasi assente, come lo fu durante il massacro. Oggi, come nel ‘94, i Rwandesi devono cavarsela da soli. L’ONU, o meglio il gruppo di paesi più potenti che ne determina le sorti, non sembra voler imparare dai suoi fallimenti. Decidere quale sia la crisi più grave o baloccarsi con l’uso della parola ‘genocidio’ non serve a nulla.