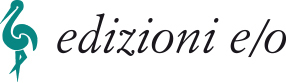L’INTERVISTA Parla la narratrice israeliana ospite della Fiera torinese e autrice de Le donne di mio padre, romanzo incentrato sulla memoria. L'insicurezza, lo spaesamento e la difficoltà di rispecchiamento tra le generazioni in Israele oggi
«La paura più profonda, per un ebreo, è quella di restare senza un tetto sulla testa. A New York la maggioranza delle persone vive in affitto, in Israele ci indebitiamo e accendiamo mutui pluriennali pur di avere una casa nostra» osserva Savyon Liebrecht. Siamo in epoca di bolla immobiliare, ma come siamo finite a parlare di mutui con la sessantenne scrittrice di Tel Aviv, già autrice delle raccolte di racconti Mele dal deserto e Donne da un catalogo e dei romanzi Prove d’amore e e Un buon posto per la notte? Savyon Liebrecht è, nella narrativa israeliana per noi italiani simboleggiata dalla triade maschile Oz–Yehoshua–Grossmann, una scrittrice di primissima grandezza. Siamo atterrate sul tema mutui cercando di capire dove possa essere germinata la storia affascinante e singolare che racconta Le donne di mio padre, romanzo – in cui il suo stile denso e secco arriva a piena maturazione – di cui parlerà qui al Lingotto – (in italiano appare, nella traduzione di Alessandra Shomroni, sempre per e/o). È la vicenda di uno scrittore trentenne, Meir Rosemberg che, in crisi creativa, si vede regalare dalla propria madre una trama a prova di bomba. Peccato che il protagonista sia lui stesso. L’obesa e malata genitrice gli svela che suo padre Aharon ventitré anni prima, non è morto, come lui credeva, ma è stato arrestato per omicidio e per ciò, lui, Meir, bambino di sette anni è stato spedito precipitosamente da Tel Aviv, dov’era affidato al genitore, negli Stati Uniti, dove la madre viveva col nonno e dove aveva un nuovo compagno, Ernie. Ora Aharon è uscito e lì, in Israele , vuole reincontrare il figlio. E la memoria congelata di Meir, che aveva fatto tabula rasa di quel periodo, comincia a sciogliersi: trentenne ricorda come, in quei cinque mesi del 1965, lui e il padre, rimasti senza casa, avessero vagabondato da un appartamento all’altro, tetti (o meglio letti) che il bell’Aharon, poeta senza un quattrino, procurava da gigolò, seducendo ogni sera una donna diversa.
C’è qualcosa di autobiografico, signora Liebrecht, in questa vicenda?«Solo un’immagine: mio padre raccontava di un sopravvissuto all’Olocausto che, incontrato per strada il suo bambino, svenne. E poi quella paura profonda e collettiva di noi ebrei riguardo al tetto sulla testa…»Nel romanzo c’è un sopravvissuto al lager, Berel, che a Tel Aviv sviene per strada e riconosce nel soccorritore, Aharon appunto, un parente che poi ospita, col suo piccolo, per alcune notti nel suo scantinato.
«Ecco la similitudine»
Il bambino Meir è un piccolo «ebreo errante»?
«Non ci avevo pensato, è interessante»
Lei è nata in Germania da due sopravvissuti alla Shoah. Ci spiegò, quando ci incontrammo nel 2002, che I suoi genitori opponevano il silenzio alle sue domande sul loro passato. Il tema di questo romanzo è appunto l’impossibilità, o il dolore della memoria?
«Sì. Io tuttora non so nulla dell’esperienza dei miei genitori e questo soggetto, il modo in cui a nostra discrezione costruiamo una memoria del passato, selezionando i ricordi o cancellandoli, è centrale nel libro. Poi c’è il rapporto padre-figlio. Ma soprattutto c’è il problema dell’arte e della creazione: Meir è uno scrittore frustrato, suo padre scriveva poesie, persino la pazza Pola, l’ex-attrice coinvolta nell’omicidio che ha macchiato di rosso i ricordi del bambino e ha condotto Aharon in carcere, ora, detenuta in casa di cura, scrive un diario».
Meir scopre il sesso ascoltando il daffare che si dà il padre nel letto accanto. Nell’ultimo romanzo di Yehoshoua Fuoco amico, è esplicito il desiderio che lega due coniugi lontani, tra israele e Africa. Oz nel suo ultimo libro ha fatto outing, nei panni di scrittore dongiovanni…
«Fantasie, in realtà è un timido. Sono le donne che, siccome è un uomo affascinante, lo stanano…»
Bene, ora di Oz sappiamo anche questo. La questione che le pongo però è: questo svelarsi plurimo dell’eros è un caso o è un segnale? Lo chiedo anche a lei, dopo averlo chiesto a Yehoshua.
«Nei nostri libri non c’è più sesso di quanto ce ne sia nella realtà. Noi siamo dei conservatori. Gli scrittori più giovani, pensi ad Alona Kihmi, loro sì sono scatenati, spavaldi».
Nei suoi racconti e romanzi precedenti il rapporto tra ebrei e arabi è importante. In Le donne di mio padre, di arabi in scena, non ne appare nessuno. Perché?
«La ricetta non li prevedeva. No, non scrivo un libro come se facessi un dolce, un tot di questo, un tot di quello. A Tel Aviv, nei primi anni Sessanta, il problema della convivenza non si poneva, è quest il motivo. E, per il resto, la vicenda si svolgeva negli Stati Uniti».
L’epilogo avviene in Israele nel 1991. Perché ha scelto quell’anno?
«Era l’anno degli attacchi di Saddam Hussein e della distribuzione di maschere antigas. Era lo scenario adatto per la sequenza apocalittica che si svolge nelle ultime pagine».
Lei parlerà qui domani. Oggi a Torino si svolgerà il corteo «pro Palestina» che suggella il boicottaggio promosso contro la Fiera. Qual è in proposito il suo sentimento?
«Tristezza. Gli scrittori delle due parti, in realtà, sono un ponte possible. E gli scrittori israeliani sono nella totalità di sinistra, eccezion fatta per uno dichiaratamente di destra, ma non è un grande nome. E allora perché prendere di mira proprio noi? »