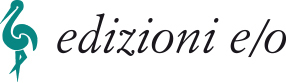Intervista. È di Tel Aviv, ha quarant’anni, i suoi genitori sono sopravvissuti alla Shoah. Scrive racconti brevissimi e surreali, che narrano per paradossi un volto sconosciuto di Israele.
Etgar Keret è un essere metropolitano. In fotografia, è vestito come un artista newyorkese off-off, il suo film Meduse, premiato a Cannes con la Camera d’Or per le opere prime, viaggia “a metà tra sogno e favola urbana”, e del resto tutto il suo lavoro letterario si muove in maniera veloce e schizzata nella meta-realtà: racconti brevi sempre surreali e pungenti come aculei, perché raccontano per paradossi com’è la vita in Israele per un quarantenne cresciuto tra contemporaneità assoluta (high-tech, musica, cultura, viaggi) e guerre, intifade, bombe sugli autobus e insicurezza. Il tema della morte, ad esempio, ha un grande spazio: nell’aldilà c’è una sorta di pianeta solo per suicidi, da un lato i kamikaze arabi, dall’altro i depressi; in un altro racconto invece, soldati uccisi continuano a interloquire con i loro compagni di reparto. Lontani apparentemente dai conflitti troviamo un prestigiatore che dal cilindro estrae un coniglio senza testa; un signore identico a un formichiere e per questo esiliato dalla comunità; animali pesanti e maltrattati; ragazze restie a farsi aprire la camicetta perché nascondono segreti inguardabili; i ragazzi desideranti ma poi, spaventati dalle donne, pronti a decidere che, per non restare soli, è meglio prendersi un cane. Insomma ansie, disagi, fatica di vivere, assurdità: il tutto con molta calma però, il massimo del cool. Tutti i suoi libri pubblicati in Italia da e/o, dal primo Pizzeria Kamikaze, all’ultimo Abram Kadabram, sorridono amari, sarcastici, ma guai alla disperazione, all’urlo: tutto è all’insegna del “non c’è problema”
Signor Keret lei si trova qui alla Fiera di Torino tra tanti altri scrittori israeliani, tutti ospiti d’onore della Fiera del libro, in occasione del 60° anniversario dello Stato di Israele: qual è il volto di Israele che porterà con sé?
«In questa Fera finalmente avremo la possibilità di mostrare che Israele ha molte facce. Nel passato lo Stato ebraico, con la sua concezione di “melting pot”, aspirava a una società omogenea, organica. Ora possiamo celebrare le nostre differenze e le nostre culture multiformi».
Ma lei quale aspetto della letteratura israeliana rappresenta?
«Non credo di rappresentare nessun gruppo etnico. Piuttosto la voce di tutti gli outsider, di coloro che non hanno mai veramente trovato una loro appartenenza»
Perché scrive sempre racconti brevi, anzi brevissimi?Sarà mai la volta di un romanzo?
«Tutte le volte che inizio un racconto penso davvero si tratti di un romanzo, ma dopo due pagine l’ho finito. Se posso usare una metafora, le mie storie hanno un’intensità che le rende simili a esplosioni, e credo sia impossibile scoppiare lentamente».
I suoi genitori sono sopravvissuti alla Shoah. In che modo questo l’ha cambiata, in che modo ha influenzato le sue scelte narrative?
«Ho imparato dai miei genitori che il nostro mondo e la nostra civiltà sono molto fragili: possono andare in pezzi in qualsiasi momento. Essendo sopravvissuti alla Shoah mio padre e mia madre mi hanno sempre insegnato a credere nella potenziale gentilezza del genere umano: mi hanno detto che, anche nelle realtà più aspre, hanno ancora incontrato generosità e coraggio».
Nei suoi racconti c’è sempre Israele. Un’Israele dipinta però come un luogo surreale: perché, che cosa ci vuole dire?
«Non voglio dire nulla di particolare, solo mostrare il mondo così come lo percepisco. Bello, pazzo, imprevedibile. Vedo le mie storie come delle piccole pubblicità della vita. Non necessariamente quella che viviamo veramente, ma la vita come dovremmo vivere».
Uno dei suoi obiettivi a volte sembra sia rompere i tabù del suo Paese, la morte di Rabin (in un racconto si chiama così un gatto ucciso da un motorino), la Shoah, i soldati morti in guerra. È così?
«Non voglio spezzare nessun tabù, solo trovare un sentiero che mi metta in una relazione intima con quelle memorie nazionali. La memoria di uno Stato ti pietrifica, mentre è quella personale che ti fa piangere. I miei protagonisti combattono per questa intimità. E lo faccio anche scrivendo le mie storie».
Ho letto che lei non lascerebbe mai Israele, anche se capisce chi lo fa. Di cosa non potrebbe fare a meno?
«Prima di tutto, in assoluto, della lingua. Come scrittore vivi dentro una lingua, esattamente come in uno spazio. Per me, che sono un autore, è un enorme privilegio abitare all’interno di un meraviglioso miracolo, una lingua che è al tempo stesso antica e moderna».
Lei porta all’estremo la situazione israeliana, i suoi paradossi: come si rapporta agli scrittori israeliani, Yehshua, Oz, Grossman, così più intimisti, così in cerca di normalità, universalità?
«Amo i loro libri, sento che è fantastico avere una scena letteraria così diversificata da contenere il loro stile tanto quanto quello di Sayed Kashua o il mio. Penso che se loro offrono delle risposte, il mio ruolo socratico, nel panorama narrativo del futuro, è quello di porre più domande».
Yehoshua l’ha criticata perché non prende posizioni politiche.
«Io le prendo, ma Yehoshua chiede nettezza, mentre le mie posizioni come scrittore e saggista contengono delle ambiguità. Molti pensano che la politica non possa convivere con l’ambivalenza. Invece io credo che la crisi mediorientale non troverà mai un’uscita se non accettando di convivere con molte sfaccettature.»
Ha vinto la Camera d’Or. Che relazione c’è tra scrivere e far cinema?
«Scrivere è come parlare, nel fare un film invece si ascolta. Amo l’aspetto collaborativo del cinema. Scrivere è meraviglioso, ma solitario. Mi piace di poter rompere la solitudine e collaborare con gente capace di tanto in tanto».
Molti scrittori arabi e alcuni uomini di sinistra hanno deciso di boicottare la Fiera perché Israele è l’ospite d’onore: come vive gli attacchi di Israele?
«Non credo in alcun tipo di boicottaggio. Sono solo il dialogo e le argomentazioni a farci fare dei passi in avanti. I boicottaggi portano solo stagnazione. Il termine “boicottaggio culturale” mi suona come un ossimoro. Non ci può essere niente di culturale, di intellettuale, in un boicottaggio».