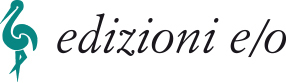Nel romanzo «Il mio cuore riposava sul suo» immagina che una lega di donne liberi il Kenya e il resto del continente dalla tragedia dell’Aids
Mercy è una donna keniota «grossa come u n a mo n t agna» e «larga come una nave» che gira in top troppo attilati e su tacchi troppo alti; è madre di uno stuolo di bambini; nata povera, s’è arricchita vendendo muratina, il letale alcool dei poveri, nei bassifondi di Nairobi, ma è stata derubata e abbandonata dal marito e, di nuovo povera, è entrata di forza in casa di Anna, giornalista italiana bianca, e le si è imposta come domestica. Mercy, come milioni di altri africani, è sieropositiva. Ma, grazie all’aiuto di Anna, curata coi costosi farmaci retrovirali, domina la malattia. E allora decide di convertire questo privilegio in un bene per tutti: suscita un movimento di donne che si battono contro Big Pharma e per l’accesso ai retrovirali generici prodotti a basso costo in India e Brasile. Mercy letteralmente s’immola per questo movimento: muore, e la sua morte pacifica e dorata, più che marcare una fine, sembra segnare un inizio. Mercy è la protagonista di Il mio cuore riposava sul suo, romanzo d’esordio che Lara Santoro, giornalista quarantunenne, cresciuta a Roma in una zona residenziale, Casalpalocco, figlia di un italiano velista e di un’americana, ha scritto in inglese e che ora e/o propone nella traduzione di Adele D’Arcangelo (pp. 261, euro 18). Perché l’ha scritto nella lingua materna? Perché è stata a lungo corrispondente prima dall’Albania e dal Kosovo, poi dall’Africa per il Christian Science Monitor e Newsweek, e l’italiano - spiega - le era ormai meno familiare dell’inglese. Lara Santoro è una donna esile dal viso singolarmente intenso. Ora vive in New Mexico: «A un’ora di strada da Cormac McCarthy» dice. Qui a Roma ha con sé Gaia, la bambina di otto anni che è nata dalla sua relazione con il «Nick» del romanzo. Perché, svela, Il mio cuore riposava sul suo è un romanzo «al 90%» autobiografico. Non fosse che Mercy, personaggio d’invenzione, a poco a poco ha cominciato a giganteggiare, acquistando una statura pari a quella di quell’altra domestica di enorme impatto narrativo, la Emerenc della Porta di Magda Szàbo... «Il libro è nato come la storia di una follia. E quindi ecco Mercy, che doveva servire da specchio a questa follia di Anna. Ma da semplice strumento Mercy mi si è imposta come personaggio, con la sua storia, le sue passioni, i suoi peccati» racconta. Aggiunge: «In realtà non ho mai saputo darle un viso. Ne ho descritto i vestiti, ma per me è rimasta sempre un’astrazione. Mercy, per me, è l’Africa».
Prima di immolarsi, Mercy riesce a condurre un milione di donne intorno al palazzo presidenziale e ottiene un incontro col ministro keniota della Sanità. Un movimento così, di donne che si battono contro l’Aids, in Kenya c’è stato, c’è?
«Magari fosse una storia vera. Sarebbe l’unica salvezza. L’ho inventato nella speranza che possa davvero succedere. Oggi in Kenya, come in altri paesi africani, sono solo un gruppetto di Ong a distribuire gli antivirali generici e soltanto un malato su quattro ha accesso a essi».
Il movimento descritto nel romanzo si ispira al «Green Belt» di Wangari Maathai, Nobel per la Pace nel 2004?
«Ha qualcosa di simile. Wangari Maathai non ha mai lavorato, però, la Nobel non ha mai lavorato su questo fronte. Peccato vista la sua autorevolezza».
Anna beve come una pazza, è divisa tra due uomini, l’elegante Nick e il rissoso generoso Michael, cameraman, che morirà in Sierra Leone; e fugge dal decidere tra i due catapultandosi qui, lì, in Nigeria, in Kosovo. Questo è autobiografico?
«Sì».
La quantità di alcol che Anna si impone, nella vita vera ucciderebbe un toro. L’ubriachezza allora ha anche
una valenza metaforica: indica l’impossibilità di affrontare l’Africa se si è in condizioni di lucidità?
«È così, in Africa il male è troppo, c’è un livello di sofferenza atroce».
Però nel romanzo affiora anche un continente pieno di luce. Dove si ride come altrove non si potrebbe. «Dalla stessa condizione di sofferenza nasce una solidarietà di cui noi ci siamo completamente dimenticati. Lì c’è “comunalità”, non sei mai solo. Gente che non ha neppure di che sfamare i figli in qualche modo aiuta il vicino di casa. Una volta, nel corso di una distribuzione di cibo del World Food Programme, ho visto una donna madre di quattro o cinque figli condividere la sua tazza di riso e fagioli con un’altra che non si era presentata per tempo. I bambini africani ridono pazzamente all’inseguimento dei palloni da calcio che fabbricano mettendo insieme le buste della spesa. Palloni che si sgretolano in mezz’ora, un’ora».
Questa solidarietà si deve a una speciale bontà oppure alla condizione in cui si vive in Africa?
«Sono qualità che abbiamo tutti, dentro. Però sono sentimenti che noi abbiamo un po’ dimenticato».
Il personaggio di padre Anselmo, il missionario della bidonville, è disegnato su Alex Zanotelli?
«Sì, anche se Zanotelli non l’ho conosciuto a fondo. Nel ‘96 l’ho incontrato nella baraccopoli di Korogocho, poi sono tornata lì molte volte: è l’unico missionario bianco che abbia mai visto vivere negli slums».
Lei è credente?
«Sì, molto. Mia madre è una protestante convertita al cattolicesimo e, come mio padre, è una fedele fervente. Per me ogni religione ha valore».
Crede che Barack Obama, per metà
keniota, potrà fare qualcosa per la
terra del proprio padre?
«La mia grande speranza è che possa allentare il ricatto cui Stati Uniti ed Europa sottopongono l’Africa: esportazioni in cambio dell’utilizzo esclusivo di farmaci brevettati. Sarebbe arbitrario e ingiusto, invece, se facesse qualcosa solo per il “suo” Kenya».