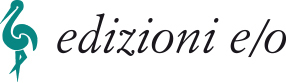Del titolo che ha inaugurato questo esperimento nippofilo, Il Giovane Robot di Sakumoto Yōsuke, vi ho già parlato. Forse dei tre romanzi finora visti è quello con un pubblico di riferimento più chiaro e magari è per questo motivo che se ne è parlato di più rispetto ai successori, che io però ho trovato più riusciti, a partire da Arrivederci Arancione di Iwaki Kei. Romanzo del 2013 premiatissimo in patria (Dazai e Kenzaburo) che a me causa un vero corto circuito, perché l’unico momento in cui l’ho sentito autenticamente giapponese è stato in un fugace passaggio in cui la protagonista africana Salima descrive la piega delle palpebre della giapponese Sayuri. Tra l’altro è anche l’unico dettaglio stonato dell’intero romanzo, perché il canone estetico della piega della palpebra mobile (pesante, singola, all’ingiù, all’insù, doppia e chi più ne ha più ne metta) non solo è inesistente al di fuori dell’Estremo Oriente, ma per il resto del globo è un concetto inesistente, quindi il pensiero di una rifugiata africana che commenta tra sé e sé la piega della palpebra di un’amica è davvero l’unico punto a tradire la nazionalità dell’autrice.
Classe 1971 e originaria di Osaka, Iwaki Kei vive ormai da venti anni in Australia e in qualche modo l’arancione che pervade il continente ha tinto così a fondo il suo stile di scrittura che a me a ricordato molto più un romanzo australiano come Orme o un Mr. Pip che qualsiasi cosa proveniente dall’Arcipelago. Uno dei risvolti più interessanti (e palesemente autobiografici) della storia riguarda la battaglia del personaggio giapponese con la scrittura, fino a riconoscere che l’unico idioma in cui possa esprimersi davvero è il giapponese. È un concetto piuttosto ricorrente in Giappone, dove tra l’altro da tradizione la lingua di Yamato ha uno spirito proprio che caratterizza la nazione e ne rafforza lo spirito identitario.
Un giapponese insomma potrebbe esprimere sé stesso solo nell’idioma che condivide la sua stessa identità. In effetti è piuttosto raro trovare giapponesi che scrivano in lingue diverse dalla propria e Arrivederci arancione spicca come un’anomalia anche perché è altrettanto inconsueto trovare romanzi giapponesi ambientati fuori dai confini nazionali. La storia si svolge in una cittadina australiana, presso la cui scuola di lingua si intrecciano i destini di tre donne che stanno lottano per motivi diversi con l’apprendimento dell’inglese. Le due protagoniste principali sono la rifugiata Salima – che oltre a dover imparare da zero la lingua è quasi analfabeta e deve quindi familiarizzare con il concetto stesso di studio – e la scrittrice e neomamma Sayuri, che fatica a parlare l’inglese ma lo comprende bene grazie alle lezioni del professor Jones. A completare il trio c’è la moglie italiana di un autoctono, una mamma chioccia di nome Paola che è la summa di qualsiasi steoreotipo buono o cattivo sulle mamme italiane noi si sia esportato nel mondo.
La lettura fila via che è un piacere, dato che il romanzo si assesta su un livello stilistico elementare, che se dapprima lo rende poco accattivante poi si rivelerà capace di potenziare la portata emotiva delle svolte importanti della storia. È come se lo scorrere del romanzo somigliasse a Salima, una donna che possiede una sua drammatica complessità di moglie abbandonata, sopravvissuta alla guerra e madre sola, ma è sprovvista di un bagaglio linguistico capace di restituirne appieno la complessità. Eppure proprio il modo rozzo ed elementare in cui piega i pochi termini che conosce per raccontare sé stessa in un tema rende le parole vibranti come mai lo sono nelle mani di persone dalla competenza linguistica più avanzata, che è un po’ la stessa cosa che succede con la linearità estrema del romanzo e del suo stile.
Il punto di vista di Sayuri invece viene raccontato quasi esclusivamente attraverso lo scambio epistolare con il suo professor Jones. È attraverso le sue missive che Iwaki Kei esplicita la sua riflessione linguistica, che è uno dei poli narrativi del romanzo. Seppur per motivi molto diversi e a livello differenti, le tre donne sono unite dalla crescente consapevolezza che la lingua sia un elemento essenziale di appartenenza a un luogo; Kei narra la progressiva conquista linguistica di Salima, che coincide con il suo mettere a fuoco ciò che desidera per sé come donna e madre. Prima è solo una x per ottenere un y, poi diventa una sensazione indistinta e familiare, quel colore arancione che combatte l’urlo dell’ombra che le sta alle spalle e le sussurra le sue paure. L’arancione è l’australe quotidiano, eppure sia Sayuri sia Salima lo ricollegano al sole visto nella loro patria, così diverso da quello che vedono qui, eppure capace di suscitare nelle due donne emozioni e nostalgie identiche.
L’altro tema cardine del romanzo è la maternità, vissuta e raccontata in una dimensione differente da quella a cui siamo abituati, in cui non si bypassa mai la propria individualità di donne, non ci si trasforma mai in madri perdendo i propri confini personali. Alle volte può capitare di fare il giro contrario e di sentirsi madri quando gli eventi negano di esserlo più, altre il dolore di perdere un figlio ancora vivo è persino maggiore di quello di vederselo strappare dalla morte.
Arrivederci Arancione lo considerei paradossalmente a chi ama la letteratura australiana, perché a me ha ricordato molto gli scrittori di quelle latitudini: rimane una lettura che occupa poco tempo effettivo per essere conclusa, ma rischia di richiederne di più per guardare dentro la sua semplicità dalla profondità inaspettata.