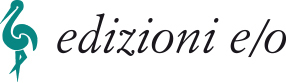Sua madre un tempo lontano era bellissima. Suonava per lei il flauto in cima alle scale e inondava di buono ogni cosa che sfiorava. Poi a Leeds sono iniziati gli inverni, uno dopo l’altro, fino a perderne il conto. Camelia diventa improvvisamente orfana. Il padre precipita in un fosso con la sua auto e con la sua amante. La madre, quella madre bellissima e idealizzata, in quel preciso istante, non potendo seguire fisicamente l’uomo che, nonostante tutto, continua ad amare, decide di restargli in qualche modo fedele lasciandosi cadere nella follia di un pozzo senza fondo, gelido come quel dicembre crudele che si ostina a durare per sempre. Nel buio della sua mente fagocita inevitabilmente l’innocenza, le attese di Camelia, ostentandole oscenamente la sua determinazione di non appartenere più a nulla. Condannata a un impietoso effetto domino, Camelia smette di studiare all’Università e “uccide” quello che la circonda: decapita le viole nei vasi, rifugge i tramonti intrisi di nuvole (sanguinolente), vomita la vita, fino a rimanerne prosciugata. Si immola per la madre, la emula e come lei diventa anoressica. Anoressica verbale. Sono i buchi, quelli morbosamente fotografati da Livia, a riempirle la bocca e la pancia di un vuoto di cui comincia persino a fare l’abitudine. Finché non incontra Wen, un ragazzo cinese di ventitrè anni che, in quell’incubo senza sonno, le regala un raggio di luce e un vocabolario tutto da reinventare. Il punto è che il sogno, quello da godersi a occhi aperti, quello con cui crogiolarsi a occhi chiusi, durerà poco. Troppo poco…
È un libro intriso di segni e simboli, questo Settanta acrilico trenta lana. Subito mi viene in mente il nome della protagonista, il cui significato nel linguaggio dei fiori è legato alla bellezza. Camelia è nel pieno della sua efflorescenza, quando viene falcidiata dall’evento tragico della morte del padre e ancor peggio dalla depressione e dall’egoismo della madre. Ma c’è dell’altro, per chi crede che nei nomi stia nascosto un destino. Il fiore della camelia ha origine in Oriente. Donarlo a qualcuno vuol dire attribuirgli stima e fiducia. Camelia si offre a Wen con tutta se stessa. Wen è il ragazzo con cui spera di ritrovare la linfa che possa farla tornare in vita. E Wen, fato vuole che sia orientale. Viene dalla Cina. Poi c’è un altro indizio: le parole. Che fine fanno le parole di Camelia? Diventano inutili, un’escrescenza mostruosa per lei, che si addestra devotamente a farne a meno, mutilandole e poi gettandole via a brandelli, in quei gorghi ossessivi che la madre, esule volontaria della vita, scatta e ferma nei flash della sua polaroid. Il fatto è che Camelia non è un’anoressica convinta. A digiuno di parole, si ritrova furtiva, quasi per compensazione, a frugare tra i rifiuti, in cerca di qualcosa da portarsi via: vestiti abortiti, con tre gambe, di misura abbondante, da tagliuzzare, su cui appiccicare qualcosa, con cui finalmente coprirsi. La sua inedia forzata si scontra con una forma aggressiva di bulimia, che travolge il lettore, lo sfida a resistere a uno tsunami, anche visivo, di iperboli, allitterazioni, metafore, architetture di proposizioni sovrastrutturate, dove la lingua è pura anarchia, brodo primordiale. Poi compare sulla scena Wen e con lui la possibilità di costruire un inedito alfabeto con cui rinominare tutto, da capo. Camelia si mette a studiare il cinese. Indaga le parole, attraverso una ritualità di tratti, numeri, colonne e chiavi che ne custodiscono ermeticamente il significato. Gli ideogrammi diventano una terapia. Camelia sta imparando a parlare. Come i bambini. Con la stessa sorpresa, lo stesso entusiasmo, la stessa avidità, la stessa impazienza e la stessa tenacia. Ma qualcosa va storto e io di certo non vi dico cosa. Anticipo che c’è una notevole suspence che tiene ulteriormente incollati alle pagine, fino a un epilogo tutt’altro che consolatorio, ma a buon vedere anch’esso inscritto nel fato ciclico di questa favola, in cui tutto suona alla stregua di un presagio sinistro: dal fosso iniziale ai buchi che ne conseguono, fino agli oblò delle lavatrici che non ho menzionato, ma sono un fermo immagine importante nella dinamica inquieta e crudele del romanzo. L’autrice, appena ventitreenne, è stata definita “dark come Amélie Nothomb e letteraria come Elena Ferrante“. Il suo libro a me ricorda invece un altro fortunato esordio, quello della Rosella Postorino de La stanza di sopra. Diversi sono i punti che accomunano questi due libri (dal sesso “salvifico” alla precarietà genitoriale, dall’anoressia -patologica e verbale- alla peculiare declinazione della morte e della solitudine), come diametralmente opposta risulta la fine, catartica per Postorino e “maledetta” per Viola Di Grado. Ma ciò che maggiormente colpisce nelle due narratrici è proprio la scrittura. Una scrittura autoptica, lacerante e strabordante, scolpita là, sul corpo perduto e riconquistato della protagonista adolescente, e qui incisa, talvolta beffardamente, con guizzo sprezzante, dentro le parole smarrite, ritrovate e ancora smarrite, di un’acerba donna. Settanta acrilico trenta lana contiene il tipico “tutto canovacciano” che solitamente si avverte nelle opere prime dei giovani. Ma esattamente come La stanza di sopra, sin dalle prime righe compie uno scarto, non solo semantico. La potenza visionaria del testo, contaminato dalle cupe e compresse atmosfere alla Lars Von Trier, come dagli echi di un certo cinema orientale, la pingue irriverenza del lessico, controllato da una sapienza chirurgica delineano un’idea netta: quella di trovarsi di fronte a un inatteso talento. Da osservare, da coltivare con la convinzione che per la letteratura di qualità c’è un presente, e forse si può ben sperare in un futuro.
- Home
- Recensioni
- Settanta acrilico trenta lana